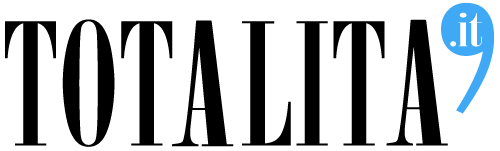Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Montagna pistoiese
Castagnacci apuani e patate prussiane -Prima parte-
Entrano nella grande letteratura del nostro latino, i necci, lungo il racconto del compagno dagli occhi senza cigli di D’Annunzio quando il poeta e aviatore rivive il tempo della scuola cancherosa alla Cicogna pratese
di Piccolo da Chioggia

Castagne apuane
Nella casa di Gavinana Pistoiese che albergava il vocabolario stampato al tempo granducale vi è una finestra aperta sulla valle del Limestre vegliata da un grazioso quadretto di arte rurale. Esso raffigura un albero al cui riparo si leva una stamberga dal tetto a due spioventi. Forse una di quelle capanne che su questa parte di Appennino sono dette metati, costruzioni nelle quali si depongono le castagne dopo la raccolta perché lentamente si asciughino prima di farne farina. La finestra del salottino minuscolo permette allo splendido panorama d’invadere la stanza e, rivolta a meridione e ad oriente, assicura luce continua, pure nei dì piovosi, fino a quando il sole non si avvia a tramontare dietro la cresta delle cime apuane. Nella cucina ottocentesca della casa, il fabbricato pare risalire intorno al 1870, ho visto appese alla parete due stanghe metalliche lunghe circa un metro che terminano senza soluzioni o saldature in due dischi del diametro che va dai ventuno ai ventiquattro centimetri all’incirca. Descrivo questo solo sull’archivio di ciò che ricordo, dato che l’uso di farmi degli appunti su di un taccuino devo ancora assimilarlo. Su di una delle due padelle, perfettamente piatte, si versa un impasto bene in amalgama di farina di castagne, acqua chiarissima d’Appennino e sale. I dischi si intendono unti a dovere d’olio d’oliva o, con migliore riuscita, di burro. Chiuso il composto versato sul disco dall’altro, entrambi possibilmente già ben caldi e posti questi nel fuoco vivo d’un focolare, dopo alcuni minuti si ritirano e il circolo coagulato dell’impasto, simile ad una crêpe francese lo si fa scivolare su di un piatto. Si ripete l’operazione fino all’esaurimento del composto ottenendo quale risultato una pila di necci di castagne, su ognuno dei quali si stenderà della ricotta per poi arrotolarlo come un cannòlo e dedicarlo alla gioia imperitura d’un ghiottone. I necci, specialità del piccolo e antico municipio della montagna pistoiese, accompagnano comunque anche varie altre varietà di cacio, e si possono servire nei modi che una fine fantasia può suggerire. Ho usato volontariamente l’aggettivo fine perché se questa ricetta è d’una semplicità disarmante, ancorchè necessiti d’una certa quale abilità nell’operazione di stendere l’impasto sul disco, chiuderlo come una foglia entro un libro coll’altro disco e allungare il tutto tenendolo per le stanghe sulle fiamme, tuttavia la vivanda ottenuta è delicata pur essendo estremamente nutriente. Con la sagacia maturata nell’esperienza di generazioni, il popolo ne ha indicato infatti l’accostamento migliore e corretto per gusto: ricotta fresca. La farina di castagne è dolce ma non stucchevole, ed è lievemente aspra, ideale per ammorbidirsi nel sapore tenue del latticino in fiocchi. Entrano nella grande letteratura del nostro latino, i necci, lungo il racconto del compagno dagli occhi senza cigli di D’Annunzio quando il poeta e aviatore rivive il tempo della scuola cancherosa alla Cicogna pratese. È una delle “faville” scoccate dal suo maglio di artefice dello stile fra le più belle. I dischi appetitosi non vengono minimamente descritti ma ricevono il nome che ancora oggi dovrebbe contraddistinguerli: necci di Gavinana, e restano così legati al piccolo borgo di lontana origine apuana arroccato all’ombra del monte Crocicchio.

La semplice vivanda, legata ad un’economia di minima sussistenza che pure, per la sua facoltà nutritiva e la sua nobile dolcezza riceve il crisma d’uno stile elevato, ha, in ragione del suo impasto elementare di farina, acqua e sale, ben tre variazioni delle quali vale di dare qualche descrizione. Il castagnaccio ne è la prima e seguono la polenta di farina dolce e le frittelle. E le composizioni delle ultime due vivande col salato o col dolce sono innumerevoli. Sembra quasi, toute proportion gardée in senso geografico e storico, che la castagna la cui coltivazione o quantomeno la cura dell’albero da cui proviene sia da ascrivere secondo l’autorità di Plinio il Maggiore ad un cavaliere atestino, Corelio, svolga o abbia svolto entro il golfo costituito dal grande arco delle Alpi e dalla loro prolunga ligure nell’Appennino che prestissimo diviene l’Apuano, l’ufficio che die Kartoffel, la patata, ha svolto presso i Prussiani del gran Federico. Se sul luogo dove riposano le ossa del re filosofo e musico ancora oggi alcuni berlinesi in segno di gratitudine popolare e commovente gettano dei tuberi sfuggiti alla cottura ed al “purée”, per l’antichità dei fatti non è possibile certo onorare in modo consimile il ricordo del bravo cavaliere dei colli Euganei. Queste poche linee sono allora il tardo e grato omaggio al lontano Corelio.
 Il castagnaccio
Il castagnaccio
Il castagnaccio è dunque l’impasto elementare abbastanza liquido e senza grumi suddetto cui si deve aggiungere un filo d’olio, pinòli e noci e, se disponibile, qualche scorza di arancia o cedro lasciate candire ovvero asciugate al naturale. Come si vede una preparazione rudimentale pure se armoniosa nei colori e nel gusto. Imburrata una teglia a bordo basso vi si versa la pastella e si mette in forno. Quando la crosta appare leggermente bruna e il tutto bene addensato, è segno che il castagnaccio è, a momenti, in via di ultimare la sua cottura. Qualche prova condotta con cura permette presto di maturare l’arte di fare questo dolce rustico e delicato. La polenta di farina dolce è data dal medesimo impasto dei necci ma, versato questo in una pentola, lo si pone sul fuoco fino a far bollire per qualche minuto. Il composto si trasmuta addensandosi e quando diviene ben consistente si toglie dal calore e si versa in un piatto. Elementare forma di nutrizione, questa polenta, detta farinata nell’Alto Pistoiese, si può consumare da sola, nel qual caso è ideale sciogliervi a fuoco spento una noce di burro e mescolare bene il tutto prima di versarla. Si accompagna benissimo ai più vari tipi di cacio e rende al meglio se accostata al cavolfiore o alle verze bollite e condite con olio, sale e aceto. Ma le possibilità di associarvi in companatico altre verdure sono, come detto, numerose. Le frittelle si fanno altrettanto con il solito impasto, cui alcuno suggerisce di aggiungere le scorze candite al naturale di cedro o arancia, e versato a cucchiai nell’olio bollente. I fagotti del composto si lasciano friggere fino a che non assumono l’invitante colore rosso-brunito che a tutto diritto, in fondo, possiamo proclamare “castano”. Queste frittelle sono per lo più consumate come dolce, non sfigurano però associate a cacio anche di sapore forte. Ho privilegiato, per questa triade, solo le possibilità “latteo-vegetariane” che rendono perfetti i connotati mentali assai rilevati di questa triade di vivande. Le quali tutte e tre si possono associare nel modo più elementare anche alla semplice frutta costituendo un pasto che, di nuovo, è nutriente in buon grado.
Nella lunga favilla dannunziana è l’ammirazione per Napoleone Bonaparte a dare un tono epico al racconto degli anni gioiosi e cancherosi trascorsi nell’augusta scuola pratese. Associare, sia pure lungo una lunga prosa rievocativa, l’ombra del grande Corso o, come lo ho rinominato, del MitraVaruna di Ajaccio ai modesti necci di Gavinana fa ad un tempo e sorridere e riflettere ove possano esserci delle connessioni oltre la trama del racconto. I buoni necci altro non sono che la vivanda modesta dei montanini quali a Pistoia vengono chiamati gli abitanti della valle del Limestre e come chiamano se stessi i fieri nativi di Gavinana, e si stenta a immaginarvi una connessione colla Parigi imperiale. Eppure non sono gli avi del Bonaparte proprio d’una stirpe che aveva nella regione apuana di Luni la propria culla? Non visita Napoleone durante la irruente campagna d’Italia un suo parente Bonaparte approdato in quel di Empoli, villa che è a pochi chilometri à vol d’oiseau dalle pendici orientali dell’Alpe Apuana? Non è irragionevole immaginare che nel nutrimento degli avi napoleonici, castagnacci e polenta dolce e forse anche necci ne avessero acuito, col loro connotato mentale, una latente linea di viva intelligenza. Dispiegatasi infine al grado del genio nel MitraVaruna divenuto imperatore.
La nutrizione è cura anche sovrana: è tramandata infatti la meticolosa attenzione che il re filosofo prussiano aveva dato alle cucine dell’esercito e in special modo ai panettieri reggimentali. Senza di loro e senza il loro pane che deve essere nutriente e gustoso al punto da essere anche un genere di conforto, le campagne non si vincono. Non ho aperto il libro della cronaca del famoso omaggio berlinese di Napoleone al grande Federico, ma dai libri di scuola si tramanda che il MitraVaruna corso abbia detto ai suoi ufficiali di ringraziare la sorte che non li aveva fatti nascere nel secolo appena tramontato perché se si fossero trovati di fronte un esercito condotto da questo re impavido non avrebbero certo passeggiato per le vie della capitale sulla Sprea. In compenso ho vivo sotto gli occhi il ricordo d’un quadro di genere dell’ottocento. Quando, lontano dalle novità neoclassiche parigine, alcuni pittori germanici coltivarono una pittura patriottica, lievemente romantica nelle atmosfere e, a volte, spinta alla retorica. Do, con queste succinte valutazioni, solo alcune impressioni del tutto individuali e senza pretesa di critica attenta e filologica. Come scritto in vari capitoli precedenti, quando imbratto di colori tele per abbellire le pareti della mia stamberga scelgo il quieto sentiero del genere astratto non gravato per costituzione dalle figurazioni. E se scarabocchio me la cavo con le ariose prospettive di case di sestiere e cupole russe specchiantisi sull’acqua lagunare. Dunque il quadro che rammento con ammirazione ha un titolo piuttosto altisonante, “der König ist überall: Friedrich der Große inspiziert den Kartoffelbau” ovvero: “il re è dappertutto: Federico il Grande ispeziona le coltivazioni di patate” e però è bello e forse anche un poco commovente per la sincerità dell’intento che relega nell’oblìo la retorica patriottica. Sulla sinistra campeggia una berlina, la famosa carrozza chiusa inventata nel 1683 da un maestro carraio torinese proprio per un nobile prussiano, e appena distante da essa si avvicina al primo piano, curvo e sorretto dal bastone, Federico ormai anziano e provato. Dietro di lui mi pare di ricordare, dato che ho smarrito il volume dove vi era riprodotto il dipinto, s’intravedesse la figura slanciata d’un ufficiale di scorta al sovrano. Era plausibilmente una di quelle famose ispezioni che mettevano in agitazione i solerti funzionari dello stato prussiano, avvertiti in genere da una lettera di mano del re che scandiva le sue osservazioni meticolose cui si aggiungevano le consuete minacce di punizione. Fra queste ne ricordo una, brevissima: “nella vostra città ancora vi sono tetti di paglia alle case. Provvedete a che siano rifatte le coperture in tegole o alla mia prossima visita mi sentirete”. Federico dunque si avvicina tendendo la mano ad un piccolo gruppo di paesani che calcano le zolle figurato in primo piano per ricevere delle patate appena raccolte che un’anziana donna gli porge. Sulla destra della rappresentazione altri paesani osservano la scena, un fanciullo a piedi nudi ha interrotto i suoi giuochi e dietro di lui con un abito dall’eleganza incompiuta dell’erudito rurale, un probabile maestro di scuola si confonde con le altre figure. Sullo sfondo i tetti del villaggio prussiano vegliati dall’immancabile campanile. Se il pane come si diceva allora, ed è stato tramandato, è la “quinta arma” dell’esercito prussiano, la patata, die Kartoffel, è l’arma di una dignitosa sopravvivenza nella allora povera regione prussiana che l’arte di brave massaie germaniche trasforma in gustosa vivanda. E il grande Federico vuole controllare coi propri occhi se al suo popolo è garantita nel modo dovuto questa sopravvivenza dopo gli sforzi richiestigli nelle lunghe guerre. La patata sta quale esatto parallelo a ciò che è stata e può ancora essere in qualche caso la castagna colla sua dolce farina per l’Appennino pistoiese e l’Alpe Apuana. Solo è qui assente un ricordo che la leghi ad un sovrano geniale; se ciò può valere di risarcimento si potrà comunque citare classicamente il passo pliniano dove si torna al cavaliere estense, l’obliato Corelio.

Oltre le regioni dell’Appennino settentrionale, e delle Alpi occidentali, e col picco plausibile della regione apuana, il castagnaccio non sembra essere comune. Se ci si allontana dalla montagna pistoiese è naturale che venga a cadere il costume di preparare i necci che richiedono oltre ai due lunghi ferri, inabili comunque a qualsiasi altro uso, una certa abilità manuale, così come la polenta dolce è sostituita dalle altre farine e dal pane non appena si scende dall’Appennino in riva al mare di Versilia o nelle pianure sui due versanti, quello modenese e quello pistoiese. Il castagnaccio, non fosse che per il nome così rude e facile da ricordare e in abito di numerose e spesso spurie variazioni, è entrato in molti libri di cucina. Il fatto di essersi assicurato qualche bella pagina a stampa non lo salva comunque dalla marginalità assoluta. È una preparazione pur nella sua semplicità troppo particolare, né il frutto arboreo donde trae ragion d’essere è diffuso capillarmente e questo non solo su tutto l’arco alpino ma pure nelle regioni sue proprie. Un caso curioso lo si ha nel Veronese e in Padova, che forse sono i due luoghi lontani dall’Appennino e dalle Alpi occidentali dove il castagnaccio è divenuto effettivamente una vivanda della quale se ne sa qualcosa anche in seno al popolo. Nel Veronese esso ha pure ricevuto un nome proprio, tratto da una contrazione nel dialetto locale. Erano fiorentini o lucchesi in Verona che, appena preparato il castagnaccio, per invitare possibili compratori nelle stagioni della farina dolce, da ottobre a marzo dicevano mostrandolo: “è calda, la bolle” donde nella città si è subito chiamato il dolce dal bel colore brunito voltandone il rude nome al femminile: “la bole”. Ci si interroga sulla data di comparsa di questa preparazione, da ascrivere all’arrivo di lucchesi, pistoiesi modenesi fiorentini nella piazzaforte militare veronese. È stato dopo il 1866, l’anno nel quale Verona dà il suo addio compiuto alla dolce Vienna? C’è chi dice sia stato solo dopo la fine della prima guerra mondiale. Difficile una risposta certa se non si abbia la “pazienza come ornamento”, della favola di Polifilo e Polìa, nel compulsare tutte le possibili cronache dell’ottocento veronese. E poi si dovrebbe esplicare anche il caso di Padova dove il dolce ritiene il suo nome rude. Nella città di Cangrande si è dunque radicata “la bole” dell’Appennino col suo nuovo e rapido nome in una guisa dovuta soprattutto alle panciute castagne prealpine dei Monti Lessini piuttosto diverse da quelle minute e di forma aggraziata delle montagne pistoiese e apuana. Anche la preparazione del dolce pare avere risentito d’uno spirito assai sbrigativo: si impasta con dell’acqua e una presa di sale la farina dolce, se si vuole si unisce o addirittura quasi si sostituisce all’acqua del latte. Si aggiunge una croce d’olio e si versa il composto nella teglia imburrata e la si pone in forno. La fine striatura cromatica delle scorze d’arancio o cedro candite al naturale è assente. Né vi sono noci o pinòli. Si carica del tutto l’ufficio del dare un corpo alla “bole” la farina tratta dalle goffe castagne panciute. La “bole” uscita dal forno ha una consistenza che è, nei casi più riusciti, quasi quella gustosissima d’un bodino addensato. Non vi sono avvisi sugli accostamenti, la si è sempre consumata come un semplice pane negli intermezzi di fame. E un tempo la vendevano addirittura nelle vie.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
Cultura
Un concerto per il venerdì santo al teatro del Maggio, tra Bach e Rossini
Un don Pasquale da ... sposare. Un grande spettacolo al Maggio Musicale Fiorentino
DON PASQUALE : l'ultimo capolavoro buffo di Donizetti tra beffe, sospiri e un tocco di malinconia
NERONE: al teatro lirico di Cagliari rinasce un capolavoro
Così é se vi pare, una grande lettura del dramma di Pirandello. Pieno successo della versione di Geppy Gleijeses al teatro della Pergola