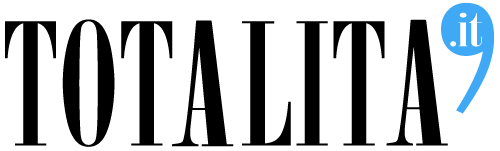Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Alexandra David-Neel
Fu una memorabile “esploratrice”, una voyageuse
L’ultima intervista della sua vita allo scoccare del centesimo compleanno
di Angelo Iacovella

Alexandra David-Neel
L’ultima intervista della sua vita, Alexandra David-Neel la rilasciò allo
scoccare del centesimo compleanno. In quella occasione, malgrado la sedia a
rotelle sulla quale era costretta e la quasi totale cecità, parlò a lungo e con
la solita grinta, un po’ mascolina, delle sue peripezie e dei suoi viaggi leggendari,
che l’avevano condotta, en mendiant, dalla Cina all’India, passando per il
Tibet, e che ne avevano fatto un mito vivente. Alla domanda su come fosse
riuscita, una dame di ottimo casato come lei, destinata a una comoda carriera
da soprano, a scarpinare per la bellezza di 3.000 chilometri, tra rischi e
pericoli inimmaginabili, fino a raggiungere le mura “proibite” di Lhasa, prima
donna occidentale nella storia, ebbene, a quella domanda Alexandra rispose, tra
il saggio e il beffardo, con queste testuali parole: “Il suffit de mettre un
pied devant l’autre…”.
Nacque a Saint-Mandé (nei pressi di Parigi) nel 1868, e si spense – fanno oggi
esattamente quarantadue anni dalla morte – l’8 settembre 1969. Ma chi fu in
realtà Louise Eugenie Alexandrine Marie David? Sicuramente una grande
«scrittrice», a giudicare perlomeno dalla fama – meritata – dei suoi libri,
primo fra tutti il Viaggio di una parigina a Lhasa (1926), e dal suo stile,
fertile e brioso. Al tempo stesso, una delle poche – forse l’unica – vera “orientalista”
della sua epoca.
Aveva studiato il buddhismo e conosceva a fondo il sanscrito, ed è a lei che si
devono testi fondamentali sull’argomento, quali il celebre e più volte tradotto
Mystiques et magiciens du Thibet (1929); un’opera indispensabile a chiunque
voglia accostarsi allo studio dell’esoterismo tibetano, le cui più riposte (e
tenebrose) pratiche dottrine l’autrice portò alla luce, come ad esempio nel
brano – un “classico” involontario della letteratura macabra – in cui descrisse
la cerimonia “del morto che danza”: Il celebrante del rito si chiude, solo con
un cadavere, in una stanza al buio. Deve rianimare il morto stendendosi su
questo, posando la sua bocca sulla bocca del cadavere e ripetendo continuamente
una stessa formula magica senza farsi distrarre da alcun pensiero. Dopo qualche
istante, il cadavere comincia a muoversi. Tenta di alzarsi e fuggire. Lo
stregone deve allora tenerlo fermamente tra le sue braccia e rimanere incollato
a lui. Il morto si agita più e più, si scuote cercando di alzarsi con lo
stregone sempre attaccato a lui che non deve allontanare la bocca da quella del
cadavere. Alla fine la lingua del cadavere sporge dalla bocca. È il momento
critico. Con i suoi denti lo stregone deve prendere la lingua del morto e
strappargliela. Immediatamente il cadavere ricade inerte e la sua lingua,
accuratamente seccata e conservata dallo stregone, diviene potente arma
magica”.
Fu, infine, una memorabile “esploratrice”, una voyageuse come mai prima se ne
erano viste. All’età di 17 anni, senza avvertire né la madre, un’anziana
bigotta di osservanza calvinista, né il padre, un coriaceo comunardo di origine
scandinava, amico di Victor Hugo, un bel giorno si imbarcò per l’Inghilterra.
Un gesto “romantico” che avrebbe bissato più tardi, allorché, diciannovenne,
lasciò la sua casa di Bruxelles, per attraversare a piedi il San Gottardo, alla
volta del Lago Maggiore, portandosi dietro, nella bisaccia, un’edizione
rilegata delle Massime di Epitteto. Lo aveva fatto, certo, per spirito
d’avventura, ma – anche e soprattutto – per sottrarsi a un clima familiare
troppo angusto per i suoi gusti, che la soffocava. Da qui l’amore per la musica
e il bel canto, e la decisione di iscriversi, dopo aver fatto ritorno in
Francia, ai corsi del prestigioso conservatorio della capitale. La sua bella
voce e il suo naturale talento per le scene non dovevano restare a lungo
inosservati, tant’è che, nel 1895, una prima e allettante offerta di ingaggio
le arrivò dal Teatro dell’Opera di Hanoi.
Alexandra si trasferisce in Indocina, dove ben presto il successo le arride,
riportandola sui palcoscenici di mezza Europa. Si avvicina – nel frattempo –
alla “Società Teosofica” di Madame Blavatsky, di cui frequenta i circoli e
dalla quale mutua l’interesse per l’occulto e per le religioni e le filosofie
dell’Oriente; interesse che, con il passare del tempo, si fa sempre più
spiccato. A Parigi, nelle austere sale del Museo Guimet, al cospetto di un
Buddha gigante, l’illuminazione. Alexandra intuisce che è quella la sua via, e
che dovrà percorrerla tutta, fino in fondo, nonostante un marito, Philippe,
conosciuto a Tunisi, con il quale conduce un tranquillo, forse troppo
tranquillo, ménage coniugale.
Il giorno fatidico e tanto atteso arriva il 9 agosto del 1911. Il richiamo
dell’Asia è troppo forte. Inutile opporvisi. Alexandra ha ormai deciso. Si
lascerà tutto alle spalle, gli spettacoli, il pianoforte, gli studi libreschi,
gli agi borghesi, per inseguire il suo scopo. Il piroscafo è là, farà rotta
verso Ceylon. Non c’è altro da fare che salirvi a bordo, e lasciare che il
karma segua il suo corso.
Un cammino lungo mille miglia, recita un proverbio cinese, comincia con un
passo. E di “passi”, Alexandra David-Neel ne avrebbe fatti eccome! Uno dopo
l’altro, si avvicina alla meta, ma troppo prolisso sarebbe seguirla da vicino
nelle sue irrequiete “scorribande” attraverso mari e monti, tra città
formicolanti e miseri villaggi, tra giungle e pagode, tra fiumi e deserti.
Meglio, con l’occasione, riprenderne in mano le opere e farsele raccontare
dalla sua viva voce quelle stupefacenti “peregrinazioni”, degne di un Marco
Polo, di un Pietro Della Valle, di un Matteo Ricci. Pagine squisite che ci
trasportano, come per incanto, dalle vette dell’Himalaya ai monasteri del
Sikkim, dove, con l’emozione della neofita, Alexandra sperimenta le gioie
dell’ascesi e della meditazione profonda (samadhi). In quel di Mando (sempre
nel Sikkim), mentre corre il 1914, un ragazzo del luogo, che passa per la
reincarnazione di un lama tibetano, si mette al suo servizio: si chiama Aphur
Yongden e, da quel frangente, le farà da guida e da fedele servitore, le starà
accanto nelle situazioni più insidiose, la aiuterà a districarsi nella
traduzione di antichi e impolverati manoscritti.
Nell’ottobre del 1923, tutto è pronto per la sfida più difficile e
apparentemente più insensata: arrivare, “senza un tenda, senza un bagaglio”,
alle soglie dello Tsi Pothala, nel cuore segreto del “Paese delle Nevi”:
“Finalmente, dopo quattro mesi (...) abbandonai Detchene una mattina all’alba
per compiere la mia ultima tappa verso Lhasa. Il tempo era bello, freddo e
secco, il cielo luminoso. Il sole che si alzava fece apparire davanti a noi,
ancora lontano e tuttavia già maestoso e dominatore, il grande palazzo del
pontefice lamaista. Questa volta è vittoria! – dissi a Yongden!”.
Il resto è prosa. Accademia. Premi, conferenze, articoli, riconoscimenti
ufficiali e non. La notizia delle imprese di Alexandra David-Neel fa
letteralmente il giro del mondo. Lei non se ne cura più di tanto, e continua
imperterrita, fino allo stremo delle forze, a vergare saggi impeccabili intorno
al prediletto buddhismo, di cui la convince l’idea dell’impermanenza dell’anima
individuale. “Siamo come onde che vivono e rivivono”: questo, a suo dire, il
succo degli insegnamenti del principe Siddharta.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da seo il 07/07/2024 23:02:51
I have bought several doors from Caldwells already. They always arrive on the scheduled date or sometimes even sooner. Contact them through their https://caldwells.com/interior-doors/caldwells-signature-door-series to order yours now.