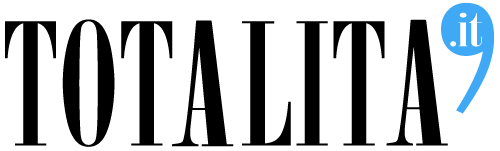Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
Editoriale
La cultura dei diritti che ha distrutto l'Italia
Non più culla del diritto ma della rivendicazione di personali egoismi passati in giudicato come inalienabili e dovuti

di Giuseppe del Ninno
 a troppo tempo i commentatori politici si baloccano, si
accapigliano, si stracciano le vesti elencando percentuali, rapporti,
statistiche, insomma numeri: debito/PIL, disoccupati, andamento dello spread,
numero delle imprese che chiudono, curve della cassa integrazione e così via,
il tutto per documentare la realtà di un paese in declino. Nello sfacelo
quotidiano che è sotto gli occhi di tutti, nelle grandi città come nelle
piccole, sulla scena internazionale come all’interno delle nostre Istituzioni, ogni
tanto affiora un personaggio, un prodotto, un primato che, per qualche istante,
sembra riaccendere le speranze, poi tutto rientra nella normalità di una
patologia nazionale alla quale nessuno pare in grado di rimediare; di più:
nessuno si mostra capace di risalire alle cause del male, primo, indispensabile
passo per avviare una terapia.
a troppo tempo i commentatori politici si baloccano, si
accapigliano, si stracciano le vesti elencando percentuali, rapporti,
statistiche, insomma numeri: debito/PIL, disoccupati, andamento dello spread,
numero delle imprese che chiudono, curve della cassa integrazione e così via,
il tutto per documentare la realtà di un paese in declino. Nello sfacelo
quotidiano che è sotto gli occhi di tutti, nelle grandi città come nelle
piccole, sulla scena internazionale come all’interno delle nostre Istituzioni, ogni
tanto affiora un personaggio, un prodotto, un primato che, per qualche istante,
sembra riaccendere le speranze, poi tutto rientra nella normalità di una
patologia nazionale alla quale nessuno pare in grado di rimediare; di più:
nessuno si mostra capace di risalire alle cause del male, primo, indispensabile
passo per avviare una terapia.
Fra gli ultimi a provarci, in ordine di tempo, Ernesto Galli della Loggia, in un editoriale sul Corriere della Sera, dove si individua l’inizio del processo di decomposizione, agli albori degli anni 70, nell’ ”avvento di un consenso elettorale ad alto tasso di contrattazione”, con il progressivo allentamento dei legami di fidelizzazione ideologica e, quindi, di stabilità dell’elettorato, e con l’innalzamento del “livello di richiesta di servizi e di garanzie sociali”. Il tutto, aggiungiamo, in un quadro di consociativismo sull’asse DC-PCI, che doveva sfociare nell’abnorme crescita del debito pubblico, causa di tutti i nostri problemi odierni.
Una simile analisi non può non essere condivisa, anche se le conseguenze che se ne possono – e forse se ne devono – trarre vanno ad intaccare tutto il corredo delle idee acquisite e delle basi stesse del “comune sentire”, non solo in politica, ma nella vita di tutti i giorni. Per illustrare questa “discesa agli inferi” dell’Italia, basterebbe confrontare due racconti per immagini, circolati in questi giorni sul piccolo e sul grande schermo: in tv, la parabola edificante del maestro Alberto Manzi, che liberò tanti connazionali dall’analfabetismo, con le sue lezioni impartite dai teleschermi dal 1960 al 1968 (anno spartiacque!); al cinema (ma subito anche sul piccolo schermo di Canale 5), “La grande bellezza” di Sorrentino, meritato premio Oscar, dove l’italico “sommario di decomposizione” si traduce in un affresco visionario, e le principali maschere della commedia italiana dei nostri giorni inscenano il loro fallimento.
Ebbene, nello sceneggiato si ritrova il ritratto di un’Italia povera ma carica di energia e di dignità, unita nella voglia di rialzarsi e di ricostruire sulle macerie del conflitto perduto, preoccupata più di ricucire un tessuto sociale lacerato anche da una guerra civile che non di reclamare diritti a 360 gradi. Ecco, l’avvento di quella “cultura dei diritti” di cui affiorano le espressioni più disparate ogni giorno sui mass media, può, a nostro avviso, essere individuata fra le cause, remote e attuali, del lento declino che ci impaluda.
I talk show, il discorso pubblico, le interviste, le nostre piazze rigurgitano di soggetti, tra l’accorato e lo scalmanato, che rivendicano diritti, alcuni sacrosanti, altri pretestuosi, altri ancora che al massimo potrebbero essere configurati come aspettative, legittime ma non dovute da alcun altro soggetto. Lo stesso lavoro, a dispetto della nostra enfatica Costituzione, è sì una condizione culturale essenziale per lo sviluppo dell’essere umano, ma non può essere oggetto di pura e semplice pretesa, meno che mai dalla mano pubblica. Il lavoro “per legge” evoca scenari di un totalitarismo espulso dalla storia fra lacrime e sangue; e se è vero che la creazione di posti di lavoro non può essere lasciata agli impietosi meccanismi del Mercato, è anche vero che allo Stato spetta non più che la creazione di norme atte ad agevolare la libera iniziativa del singolo, che si tratti di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti, di liberi professionisti o d’altro.
Oggi invece, specialmente da noi – e con la connivenza, se non con il sostegno di alcune forze politiche e di alcune agenzie culturali – tutto è oggetto di diritti e, quanto ai doveri, al massimo si agita lo spettro del dovere contributivo, quale controparte di uno Stato che si deve occupare di tutto, dalla culla al letto di morte del cittadino, e che conseguentemente ha bisogno di risorse crescenti, magari per dissiparle. Pensiamoci: riteniamo di avere diritto ad avere un figlio, con qualunque mezzo messo a disposizione della scienza e delle leggi, ma anche a risolvere il vincolo matrimoniale; ad essere promossi a scuola, anche se siamo somari; ad essere assunti stabilmente, preferibilmente dalla Pubblica Amministrazione, anche ove quest’ultima di assunzione non abbia necessità, o ad accedere a finanziamenti pubblici, in una delle infinite possibili fattispecie, senza alcun obbligo di rendiconto; di impedire o di spostare “altrove” grandi e piccoli lavori, visti come turbativa delle nostre abitudini e sicurezze; accampiamo perfino la pretesa di far adeguare la Chiesa alle nostre esigenze, che si tratti di contraccezione, di eutanasia, di disciplina dei matrimoni, sempre nel nome dei “tempi che cambiano”, dimenticando che la Chiesa opera nella prospettiva dell’Eternità.
Sotto il profilo antropologico, questa onnipervadenza della “cultura dei diritti” ha dato luogo alla prevalenza di un tipo umano ben peggiore di quello appena uscito dalla guerra mondiale: un tipo umano che aspetta dall’alto o che tenta di strappare indebitamente quello che pretende essere un suo diritto, senza assumersene la responsabilità (basti pensare alla pratica diffusa dell’occupazione di luoghi pubblici come il Teatro Valle di Roma o di cento e cento edifici strappati ai legittimi proprietari, il più delle volte pubblici); un tipo umano che non ha più voglia di intraprendere o di far valere i propri meriti attivamente, nel quadro di una struttura gerarchica (ovviamente, al netto dei pur tanti esempi lodevoli di segno contrario e positivo, che però vengono soverchiati dalle masse che reclamano diritti a torto o a ragione).
Inutile sottolineare che il riconoscimento di diritti, “veri” o presunti, rientra nel quadro di quella “contrattazione” deplorata dal Galli della Loggia, e riferita tanto alle organizzazioni sindacali quanto alla classe politica; una tendenza alla contrattualizzazione di ogni rapporto, con il corrispondente, progressivo sfaldamento di ogni Potere, per tacere del possibile scivolamento della contrattazione verso la palude infetta della pressione, della corruzione, dello scambio illecito. In un simile contesto, anche il discorso sulla cittadinanza, che vede su fronti contrapposti i fautori dello “ius soli” e quelli dello “ius sanguinis”, rischia, fra l’altro, di creare nuove falangi di perenni scontenti, pronti a chiedere sempre di più, crisi o non crisi.
Perché di un aspetto ci si dimentica troppo spesso: della natura comunque transeunte, “storica” dei diritti. Tolti quei pochi che possono essere inquadrati nello statuto naturale dell’uomo, tutti gli altri diritti, lungi dall’essere acquisiti per sempre, sono figli del loro tempo e delle risorse che quel tempo è in grado di generare.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da Cosma il 06/03/2014 14:28:46
Giustamente Lei scrive, dott. del Ninno, che "una simile analisi non può non essere condivisa. Tuttavia andrebbe anche osservato che Galli della Loggia, nel suo articolo, sembra troppo preoccupato di scaricare le colpe sulla società civile e di difendere i partiti politici. Se avesse anche aggiunto che la Costituzione parlamentarista ha trasformato quella stessa Carta nella fonte dei mali d'italia, il quadro sarebbe stato più realistico; anche se, forse, questo sul Corriere della Sera è opportuno non scriverlo.
1 commenti per questo articolo
il Banditore
Non possiamo nn dirci conservatori, e allora attenti con la santificazione della tecnologia
Quel che la Corte Suprema non ha considerando riguardo al divorzio
Perché la destra sta sparendo dall'agone politico
Mettete la museruola ai genitori incoscienti
Se le donne vincono quando in politica i migliori rinunciano