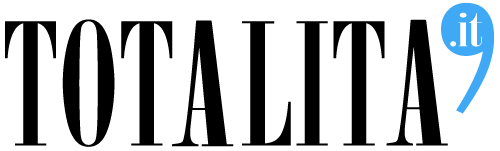Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Memorie
La presenza dell'Inattuale, il "mio" Bartolini
Se dovessi scrivere un saggio su di lui lo intitolerei "Illazioni su una seggiola impagliata"
di Franco Cardini

Si può mai cominciare una pagina bianca con la parola “Conobbi”?
Sigfrido, ch’era uno stilista spietato – conosco soltanto Pasolini più rigoroso di lui –, non me lo avrebbe forse mai perdonato: peraltro, il perdono non era esattamente la virtù cristiana ch’egli prediligesse e che più volentieri praticasse. Il che, in lui, era d’altro canto etimologicamente parlando una contraddizione in termini.
Nelle lingue germaniche, il verbo che indica il perdono è strettamente collegato con quello che rimanda al concetto dell’oblìo: come se, in quei popoli ancestralmente radicati nei valori della Fehde e del Vergeld, della vendetta e del “prezzo del sangue” (“faida” e “guidrigildo”, nel linguaggio del nostro diritto arcaico: due parole che a Sigfrido certo piacevano), l’unico modo di perdonare un’offesa fosse, in realtà, dimenticarla.
Nei popoli di stirpe latina, invece, per-donare significa “donare in modo paradossalmente, eccezionalmente, esageratamente generoso”. E questo sì, lo scialare dei sentimenti, lo scialacquare delle passioni, gli sarebbe andato a genio.
Confidando quindi nella generosa capacità di perdono (nel senso che ho detto) di Sigfrido Bartolini, comincerò sul serio con la parola “Conobbi”: che però, per prudenza, ho fatto in modo di collocare qualche rigo dopo l’inizio del discorso.
Ebbene sì, dunque. Conobbi – «ora, o malanno, tu sei combinato», come fa dire Shakespeare a Marco Antonio – Sigfrido Bartolini nell’ormai non più vicinissimo 1975, quando né io né lui eravamo più propriamente giovanissimi.
Lo conobbi, dico, di persona, in quanto di fama lo conoscevo da tempo mentre lui aveva letto qualcosa di me. E mi stupii del fatto che fosse “appena” quarantatreenne, un’età che anche allora, pur non essendo proprio verdissima come i quarantatreenni d’oggi vogliono farci credere, era pur sempre giovanile.
Me ne stupii non per il suo aspetto, dal momento che Sigfrido, come diciamo noialtri, condivideva la virtù della gallina mugellese, che avrà cent’anni eppur dimostra un mese: a prima vista aveva l’aria di un ragazzino, bisognava guardarlo bene per rendersi conto che un po’ d’anni ce li aveva (lascio appunto a stilisti e a dialettologi il decidere se s’abbia a dire “mugellese” o “mugellano”, argomento sul quale da noi les avis sont partagés).
Me ne stupii in quanto, lettore ammirato dei suoi scritti ed estimatore affascinato per quanto incompetente delle sue opere d’arte, mi ero fatto senza conoscerlo e senza aver mai letto un suo profilo biografico l’idea che fosse coevo del “sor” Ardengo Soffici o di Ottone Rosai o di Primo Conti, ai quali lo avevo sempre avvicinato. Scoprirlo non proprio mio coetaneo, ma quasi, fu – lo confesso – sulle prime una piccola frustrazione: lui era già famoso e io non ero nessuno.
D’altronde, con Sigfrido ci si sentiva sempre inferiori: ma il disagio di sentirsi tali scompariva quasi subito parlando con lui: dopo la prima risata, il primo bicchier di vino, la prima parolaccia. Se si scopriva di andarci reciprocamente a genio, beninteso. Tra noi due, successe.
Era appunto il 1975: avevo un incarico universitario che non si era ancora trasformato in cattedra e non giravo all’unisono né con l’università, né con la società, né con le idées reçues del mio tempo. Ero uno di estrema destra per quelli di sinistra, di estrema sinistra per quelli di destra; ero troppo cattolico per laicisti e non credenti, troppo libertario per credenti e clericali. Anche per quello, con Sigfrido bastò una reciproca annusata, come fanno i cani: anche se ci riconoscemmo subito – tanto per continuar col paragone animale – come entrambi appartenenti piuttosto alla razza dei gattacci randagi.
Ci aveva fatto conoscere, certo che ci saremmo andati a sangue, l’editore Giovanni Volpe: un altro che celava dietro il suo fisico imponente di vecchio signore alto, elegante, barbuto e canuto la sua vera natura, a sua volta, di felino da strada. Giovanni Volpe era figlio del grande storico Gioacchino e ricordava molto nel suo aspetto fisico un suo illustre omonimo, Giovanni Gentile. Era stato fraterno amico, da giovane, del mio maestro universitario Ernesto Sestan, che di Gioacchino Volpe era stato segretario ai tempi dell’Accademia d’Italia: anche se, nell’immediato dopoguerra, le loro rispettive opzioni politiche ne avevano un po’ raffreddato i rapporti. Giovanni Volpe, come editore e come uomo, era a sua volta generoso ben oltre i limiti della prudenza: stampava i libri che gli piacevano, andava regolarmente controcorrente, pettinava contropelo tutti i conformismi del suo tempo e se ne fregava di rimetterci di tasca sua.
Ci vedevamo abbastanza regolarmente a San Miniato al Tedesco. In quegli anni, chiunque dicesse che il duomo di quel bellissimo centro del basso Valdarno caro alle memorie di Federico II di Svevia lo avevano fatto saltare nel ’44, con tutta la gente dentro, non i tedeschi bensì gli alleati – sia pure a causa di un incidente preterintenzionale – rischiava quantomeno di prendersi del nazista: eppure lo sapevano praticamente tutti, anche se ci sarebbe voluto circa un quarto di secolo prima che la verità fosse riconosciuta ufficialmente (e controvoglia).
Giovanni ospitava ogni anno regalmente a sue spese qualche decina di studenti liceali e universitari in un vecchio, bell’albergo di San Miniato, proprio sotto la rocca federiciana, per una serie di lecturae Dantis titolare delle quali era un altro carissimo amico ora purtroppo scomparso – e anzitempo, ancorché dopo una malattia durissima che lo accompagnava fin dagli anni della prima gioventù: quel Marco Tangheroni, medievista dell’Università di Pisa, che ancor oggi è ricordato come uno dei più geniali storici italiani ed europei del XX secolo. Erano lecturae Dantis storicamente e filologicamente irreprensibili ma, a loro volta, non propriamente ortodosse sotto il profilo dei valori politico-intellettuali allora prevalenti e prepotenti. Io “davo una mano” a Giovanni e a Marco: tantopiù che Tangheroni ed io, in quanto medievisti, eravamo ammiratori devoti dell’opera di studioso di Gioacchino Volpe.
Fu appunto l’editore-mecenate a presentare sia me, sia Marco, a Bartolini. E nacque in quella sede, ovviamente a tavola, l’idea di fare insieme un libro. Io avrei dovuto presentare, pubblicare nel testo latino e tradurlo “a fronte” in italiano, un trattato del XII secolo che un altro dei miei Maestri, Attilio Mordini (filologo germanista, studioso di Tommaso d’Aquino, terziario francescano: anche lui scomparso poco più che quarantenne nel giorno di san Francesco del ’66, l’anno dell’alluvione), mi aveva insegnato ad amare: il Liber de laude novae militiae che Bernardo di Clairvaux, il doctor mellifluus, aveva scritto in onore dell’Ordine Templare, da pochissimo costituito proprio grazie alle sue insistenze presso il papa.
Sigfrido non conosceva direttamente quel testo medievale: ma sapeva bene di che cosa si trattasse, e a lui non meno che a me piaceva questa geniale e paradossale invenzione del nostro Medioevo cristiano, l’idea di coniugare la dimensione del “monaco” con quella del guerriero. Accettò dunque subito la richiesta di corredare quel libro con alcune sue xilografie.
Mi aspettavo due o tre capilettera: di lì a poche settimane, mi arrivò un fascicolo ricchissimo d’immagini formidabili. Ne venne fuori – e non certo per merito mio – un bellissimo libro di grande formato, in carta a mano, che ormai è una rarità bibliografica (valutata, mi dicono, alcune migliaia di euro a copia) perché Sigfrido “biffò i legni”, come si dice.
Mi diverto ancor oggi, di quando in quando, riguardando quelle pagine, quelle illustrazioni: e scoprendone ogni volta un aspetto nuovo, un nuovo messaggio segreto e allusivo dei moltissimi che Sigfrido aveva disseminato nei particolari delle immagini. Di lui e della sua opera, qualcuno ha detto che “non finiscono mai di sorprendere”. Bene: non è solo un modo di dire.
Eppure, non è quel Sigfrido “medievale” – a parte la qualità di quell’opera e la memoria ancora gradevolissima di quella collaborazione – il Bartolini che preferisco, quello dove il suo cuore pistoiese parla al mio, fiorentino di San Frediano. Già il rapporto paradossale tra il suo nome e il suo cognome mi stupiscono e mi sembrano un segno del destino. Ha detto davvero bene di lui un altro comune carissimo amico, Stenio Solinas: «In Italia, patria del melodramma, venire al mondo col nome di Sigfrido è già un segno del destino. Per bene che ti vada ti attende una vita controcorrente. Nomen est omen, dicevano gli antichi. Avevano ragione…». Proprio così.
Un cognome semplice, comune, umile, da figlio di verniciatore e “filettatore” che s’è sempre vantato di esser tale: un cognome che da solo la dice lunga sulla profondità delle sue radici popolari, da toscano di quella pianura che da una parte sente già la voglia di mare – il Tirreno è là, vicino – e dall’altra s’arrampica su per la montagna appenninica, verso la Pavana di Guccini e la Gavinana di Ferrucci.
È un nome da eroe destinato a vincere i draghi e ad impararne il segreto linguaggio, Siegfrid, “la Pace della Vittoria”. Certo, un bel contrasto: «Sarebbe come chiamarsi Lapo Wagner», mi disse una volta. In termini di rovesciamento e di paradosso, sì. In termini simbolici – nomen est omen, appunto – significa però ben altro. Bartolini ha fatto onore, vivendo, alla sua razza di toscanacci ruvidi e di raffinati artigiani. Ma Sigfrido ha reso omaggio e procurato gloria a se stesso: al suo coraggio di uomo e di artista, al suo sconfinato amore per i Draghi della fantasia e alla sua vocazione di Ammazzadraghi, quegli altri draghi, quelli con la “d” minuscola. I rettilacci del conformismo, del falso genio, del successo facile e ruffiano, del labile e mercenario consenso.
Tutt’altra razza, di “rettili” solo nel peggior senso traslato, indegna dei rettili veri, domestici, dei geni loci protettori dei nostri antichi focolari domestici: i bei gechi pacifici e calligrafici che prendono il sole sulle pareti delle nostre case toscane proteggendole dal malocchio e dalle zanzare; oppure le simpatiche tartarughe da giardino, come quelle che stanno sul retro della casa di Pistoia e che Sigfrido amava (salvo invidiarne, a quel che mi dicono, i lunghi e frequenti exploits amorosi).
Non è comunque, dicevo, il Bartolini medievista, quello del libro sui Templari o magari delle pur belle vetrate a modo suo “neogotiche” dell’Immacolata, quello che prediligo. Non è il Bartolini eroico, quello delle memorie o delle ispirazioni dannunziane, che pure per tanti versi – non tutti… – andavano tanto a genio sia a lui, sia a me. Non è nemmeno il Bartolini polemista e stroncatore di tanti scritti raccolti ne La grande impostura, che pure ci hanno insegnato alla grande, con un piglio e una grinta che sarebbero piaciuti al Papini più indignato e al Soffici più spietato, quello che preferisco. Mi piacciono, certo, mi vanno a genio, ci ho imparato tanto e qualche volta ho fatto anche tesoro del loro insegnamento e ancor più del loro spirito intimo, per quel po’ che sono riuscito a cogliere e a penetrare. Lì, però, c’è soprattutto e a mio avviso anzitutto il Grande Bartolini. E va bene.
Io però, quando nessuno mi sente né mi vede né mi legge né mi ascolta, preferisco uscire dalla porta secondaria, quella che dà sull’orto della casetta di campagna che non ho mai avuto e non avrò mai ma che è lì nell’angolo nascosto del mio mondo; e prendere il viottolo dei miei pensieri e dei miei ricordi più intimi. Ed è lì che ritrovo il “mio” Sigfrido. Quale? Ecco qua.
Il più bello tra i molti bei libri di Claudio Magris, o almeno quello che io preferisco – addirittura più di Danubio: che, per me, è tutto dire – è Illazioni su una sciabola: dove, partendo da una vecchia sciabola cosacca, si ricostruiscono con severo rigore, ma anche con molta pietas, le tragiche vicende dei cosacchi finiti nel ’44 in Carnia al seguito della Wehrmacht; quelle stesse che, in Friuli, ispirarono al giovane Pasolini parole che non si dimenticano e che rimangono a mezzo millennio fa, alla memoria delle incursioni turche.
Ecco, per analogia rispetto a Magris, se dovessi scrivere un saggio su Sigfrido lo intitolerei Illazioni su una sèggiola impagliata. “Sèggiola”, non sedia: le sedie son roba da signori e da signorini, al massimo da salotto “bòno”. Ma non è su una sedia che ci si accomoda nelle lunghe sere d’autunno, davanti al fuoco, magari accanto al fiasco, o che si sosta all’imbrunire nell’orto alla fine di quei chiari e afosi pomeriggi d’estate, a godersi un insperato e atteso rèfolo di vento. È seduti su una sèggiola che si ragiona, ch’è una cosa diversa sia dal parlare, sia dal discutere; e che si ricorda, o si rammenta.
“Rammentare” vuol dire richiamare alla memoria nutrita di ragione; “ricordare” rimanda però non alla testa bensì al cuore, non al giudizio bensì al sentimento. Quando mi ricordo/rammento di Sigfrido, è così che ci ragiono. Della nostra terra, degli amici che non ci sono più e di quelli rimasti, del mondo perduto e di quel che ne resta, di quel che invecchia e di quel che non si logorerà mai perché è eterno e nessuno può distruggerlo, nessuno può togliercelo.
E in quelle sere autunnali che già annunziano la stagione fredda, in quei tramonti d’estate quando il caldo cede alla frescura, si apprezzano di più le sèggiole impagliate come si facevano una volta e ormai non si fanno più, e per fortuna quelli della Ikea non hanno imparato a scimmiottarle, e forse purtroppo da qui a qualche mese magari ce ne arriveranno delle fredde, perfette copie made in China.
Sono le sèggiole di cui Sigfrido ha disseminato il suo Pinocchio, insieme con le cappe del camino, con i grilli e con i martelli, le sgorbie, insomma gli utensili da falegname come quelli usati da Gesù di Nazareth e da Geppetto, tanto simili – e talvolta identici – a quelli dell’incisore sul legno, dello xilografo, del pittore-scrittore abituato a lavorare con le mani e a “pensare” con le mani: sempre, anche quando quelle mani cominciano a rattrappirsi, a non obbedirgli più come una volta, ad abbandonarlo, a tradirlo. In fondo, Pinocchio è un alter Christus (come il Sigfrido del Nibelungenlied); e ogni Pinocchio, ogni Sigfrido hanno il loro Giuda. Talvolta penso che le sue mani sono state il Giuda di Sigfrido Bartolini: eppure, Giuda amava il Maestro. Nessuno saprà mai quanto lo amasse. Nessuno prega più per lui, il Traditore, il Reietto, il Rinnegato. Nessuno pensa mai che, mentre Pietro rinnegava il Maestro, Giuda era il primo a morire per Lui. Morire di rimorso, di vergogna; ch’è un terribile morir d’amore.
Sigfrido, ch’era un grande Maestro d’arte, se n’è sempre sovranamente fregato delle mode, delle tendenze, degli stili. E del successo. Ha sempre disegnato, inciso, scritto quel che gli è parso e gli è piaciuto, come gli è parso e gli è piaciuto. Ha sempre badato a conservare intatta e vergine la sua libertà. Si è sempre sentito parte del suo popolo, ma non ha mai amato la popolarità.
Come diceva Francesco d’Assisi, bisogna cercar di esser santi ma non farsi belli gloriandosi della santità altrui. Sigfrido non si è mai imbrancato nella reciproca ruffianeria dei premi, delle cordate, delle combines, degli scambi di favori, della fama confezionata nei salotti, nelle sagrestie, nelle cellule, nelle logge e nei retrobottega. Non è mai corso in aiuto ai vincitori del momento, non è mai saltato sul predellino dell’auto “giusta”.
Ha fatto l’artista perché era un artista. È stato marito, padre, amico; ha parteggiato, senza paura di abbracciare anche le “cause perdute” quando gli sembrava giusto farlo. Ha saputo perfino essere nobilmente e appassionatamente fazioso: perché chi è tiepido viene vomitato dalla bocca di Dio e perché solo i violenti meritano il Paradiso.
Sigfrido, così sferzante e spietato con chiunque disponesse di potere e dimostrasse di vivere per l’Avere e per l’Apparire anziché per l’Essere, ha sempre amato i vinti, gli umili, i nascosti. Gli Ultimi.
Le vetrate dell’Immacolata, una delle sue ultime opere, non sono solo un’opera d’arte: sono anche un’ennesima opera di bene e di carità, proprio come le “Opere di Misericordia” che rappresentano e che rimandano a un grande capolavoro del Rinascimento pistoiese.
Era molto frequente che Sigfrido non si facesse pagare per quel che faceva. Per quella generosità in lui innata, quella che per-dona, cioè che dona intensamente e perfino eccessivamente. E magari anche (soprattutto?) per un senso profondo, altissimo, prezioso eppur a suo modo terribile, di Superbia con la Esse arcimaiuscolissima. La Superbia ch’è la consapevolezza certa e incrollabile di chi sa di essere, letteralmente, impagabile.
In quelle sèggiole dalla paglia vecchia, consunta, sfibrata, magari provata da decenni di sfregarsi di ruvidi indumenti di vecchi, di giocar di bambini, di rosicchiar di tarli e di arrotarsi le unghie di gatti domestici, c’è una saggezza che non ha prezzo. Ci sono l’amore, la miseria, il dolore, l’attesa, la pazienza, la rassegnazione, la costanza, la fedeltà, le fiabe raccontate ai bambini e le storie dolci o penose ricordate a fior di labbra.
«Ho finalmente fatto un’opera per il popolo». È questo che ha detto, a proposito delle sue vetrate. Ma lo aveva detto centinaia di migliaia di volte. Dipingendo, incidendo, scrivendo, litigando. Amando, come sanno amare soltanto i solitari di gran razza.
Con una passione che di tanto in tanto, per non sfociare nella tragedia, si tinge d’ironia: ed è allora che diventa più efficace, più profonda, più alta, più vera. Sigfrido Bartolini, l’Inattuale.
Bartolini, per Sempre.
Sigfrido, Presente.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da piccolo da Chioggia il 31/03/2014 21:49:08
lo rileggo sempre ammirato. sulla sèggiola racconto anch'io qualche favola ma preferisco ascoltarla. e sbocconcellare una fettina di castagnaccio con qualche dado di cacio pecorino. o con qualche frutto secco. basta pochissimo.
1 commenti per questo articolo
Attualità
Il professore e la dignità della scuola; una battaglia da Don Chisciotte?
EI FU. L'anniversario di un personaggio sicuramente controverso, ma le vestali del politically correct ....
IL KULTURKAMPF DELLA SINISTRA AMERICANA: il mito del piagnisteo che non finisce mai.
GIULIO REGENI: tra verità nascoste e ragione di stato.
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; la spada dell'arcangelo ci protegga dai moderni iconoclasti!
Il Fatto del Giorno
EI FU. L'anniversario di un personaggio sicuramente controverso, ma le vestali del politically correct ....
GIULIO REGENI: tra verità nascoste e ragione di stato.
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; la spada dell'arcangelo ci protegga dai moderni iconoclasti!
Il Biopotere: complottismo o incubo prossimo venturo, anzi già in corso?
La Messa per Pasqua? Inutile, si può pregare anche in bagno!