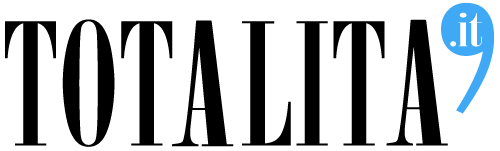Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Per la strana connessione di scambi nei binari lungo i quali muove la nostra vita
Fantasie fumisterie letture e passeggiate notturne
Non è raro che nella solitudine della mia camera, quando la pendola dell’orologio del Duomo già rintocca le ore piccole ponga mano alla matita e lasciati al pomeriggio gli ultimi scarabocchi mi dia a ritrascrivere delle frasi da autori che ammiro
di Piccolo da Chioggia

Da sinistra in alto: Prezzolini, Papini, Jünger, P. E. Pavolini
Non era stato che solo un paio di occasioni per le quali incrociavo, lungo la mia salita alla biblioteca dell’università, la flotta delle ottuse berline del prestigio economico e i loro conduttori e passeggeri e ammiratori. Il resto delle sere era all’insegna del quieto incontro con gl’insonni bibliotecari e degli allegri racconti con le bibliotecarie, curiose della mia ventura di lettore e scarabocchiatore capitato lì, a frugare negli scaffali, per la strana connessione di scambi nei binari lungo i quali muove la nostra vita. Non ho quella paziente tenacia nella ricerca archiviaria che nel mio caso di lettore a lenta riflessione finirebbe per generare fatiche improbe con modesti risultati. Resto perciò ancorato alla superficialità e sfoglio i libri leggendo a frammenti perché confido d’incontrare quel verso, quell’immagine, quella massima, quella figura che mi si imprima con velocità e indelebile nella memoria che addestro a tale ufficio.
Albert, era il primo dei bibliotecari con i quali ho cominciato a conversare. Aveva voglia di chiacchierare ma non per esibire i suoi taglienti giudizi di lettore incomune. Semplicemente perché in una università, dove un curioso cartello tutto svizzero avvertiva dell’esistenza di un centro d’ascolto psicologico, stanti la fortissima competizione nutrita di ambizioni da futuri napoleoni della finanza fra studenti e pure fra docenti, un perditempo serale in vena di letture inusuali per il luogo metteva in moto l’atmosfera del suo bancone costellato di schermi elettronici. Ad un certo punto, e non so come si arrivasse sul discorso, Albert mi raccontava d’una sua lettera inviata, quand’era ancora studente, a Ernst Jünger e trascritta da questi sulla sua pagina serale e tale così da divenire tessera di quella lunga novella che è la raccolta dei suoi diari. Ricordo ancora i titoli dallo stile spiccato e inconfondibile che ritmano le annate, Gärten und Strassen, “giardini e strade”, i diari di Parigi lungo gli anni di guerra, dall’ingresso vittorioso ma in trepida attesa del 40 all’abbandono deprimente del 44. Con un intermezzo nel lontano Caucaso. E poi Siebzig verweht, “trascorrono i settanta”, cronaca dei viaggi nei vari continenti oltremare in quegli anni della transizione europea, dove sono descritte le ulteriori cacce minime di insetti nuovi e strani che frutteranno al genio di Hannover la scoperta d’una nuova specie di farfalla cui verrà apposto pure il nome di Jüngeriana.
Affiora pure il ritratto a brevi pagine del fratello musicista e matematico che pare fosse giunto alla soluzione d’un famoso problema rimasto insoluto da secoli e viveva in uno stato di volontario e sereno ritiro in una casetta nei pressi d’una chiesa della quale era l’organista. Nella Germania orientale. Leggevo tutto nel tedesco cristallino del petit boche e mi meravigliavo di come mi riuscisse facile la lettura. Se ad Albert dunque dovevo le bellissime ore notturne passate sul diario jüngeriano, e qui va detto che la biblioteca presta i libri anche agli estranei cui viene data una tessera ad hoc, così lui doveva a me la lettura delle schegge di Papini che io stesso avevo scoperto entro le scansìe dedicate alle lettere italiane. Una mattina di pioggia, sempre del tardo autunno lo avevo incontrato mentre, in piedi, armeggiava sulla scrivania del suo posto di comando e vedendomi mi ringraziava della scoperta che lui, insonne lettore svizzero, aveva fatto del fiorentino.
Lontano dalla città veneta, anche se colpito dalla bellezza del paesaggio di quel lembo di Svizzera orientale, la notte, al ritorno dalla passeggiata, a volte volevo leggere in italiano, ufficialmente per non affaticarmi gli occhi, che al mattino avrei dovuto esercitare sulle assonometrie e sul ricalco alla debole luce dell’autunno. In realtà per ricostruire, filtrato dalle maglie fittissime di quel setaccio che è una lettura di libri su cose passate, i paesaggi interiori, esterni su lembi d’uno spazio che conosco o che il genio di chi scrive mi possa adombrare e far rivivere, vedere nel senso più lato. Le lettere scambiate fra Papini e Prezzolini al tempo lontanissimo di Lacerba mi lasciavano intravedere una Firenze ideale, becera ma simpatica e più che europea non solo per le frustate dei fiaccherai insolenti ai ronzini sulle carrozze ovvero sulle isvoscie che recano gli epigoni stranieri del gran tour ottocentesco.
Prezzolini con arguzia descriveva il D’Annunzio che sale a Settignano col cavallo incontrato da lui e Papini che ostentatamente non degnavano d’un solo sguardo il cantore delle Laudi. Ripensavo ad Angelo De Gubernatis il professore piemontese venuto a Firenze ad insegnare il sanscrito, a Paolo Emilio Pavolini, livornese che in quell’ultimo intervallo di belle époque consegna alle lettere italiane il Kalevala tradotto nei nostri ottonari e poi ilMahabharata e la sua massima che schiaccia come sotto i cingoli d’un carro armato le velleità di chi si crede poliglotta perché ciancia in inglese e francese qualcosa: le prime dieci lingue si fa fatica a impararle ma, dopo, le altre vengono facili. Lo aveva detto alla nipotina Maria Vittoria, figlia di suo figlio Alessandro, lo scrittore di “Scomparsa d’Angela” e di “Nuovo Baltico”.
Sono a volte quattro o cinque i volumi che dalla biblioteca, alla chiusura poco prima delle ventiquattro, mi porto nella camera dove abito. Ma non sempre mi immergo subito nella lettura con la solerzia del simpatico Buchwurm ritratto dallo Spitzweg. Restano infatti gli strascichi delle ultime conversazioni con le bibliotecarie con le quali sempre mi attardo, due donne, una bionda e una bruna, alle quali entrambe non difetta in alcun modo una acuta ironia verso i pomposi professori della facoltà. E qui credo proprio non si tratti del risentimento dell’impiegata con chi tratta con lei in posizione di superiore pur senza essere colui che può darle degli ordini (anche se, spesso, dà le fastidiose incombenze di cercare volumi con titoli illeggibili) ma dell’essere scettici in chi vede da troppo vicino che i sommi pontefici delle gran teorie, in ispecie quelle economiche, in realtà danzano con formule e proposte per ritrovarsi ciclicamente come nel gioco dell’oca alla casella d’inizio. D’altra parte, la finestra della mia stanza dà, sulla stretta via, una gasse, appena adagiata sulla costa del Rosenberg, a oriente dove la casa di fronte lascia intravedere una buon settore del notturno cielo autunnale che invita a perdersi in pensieri.
Leggo qualche riga ma subito fantastico se nelle descrizioni dell’autore si veda un barlume di paesaggio. Nel primissimo carteggio Papini Prezzolini, è la Firenze europea al crepuscolo dei filosofi che mi torna alla mente. La ricostruisco in un quadro nel quale si sovrappongono le geniali allusioni dei due fiorentini nelle lettere a ciò che rammento delle mie passeggiate e da foto assai antiche. Qui devo aggiungere per chiarire che ho sempre ammirato e osservato colla massima attenzione quelle foto Alinari dell’avvio del xx secolo dove le nude architetture nelle città italiane apparivano ritratte colle modeste costruzioni ad esse propinque in una fantastica isolata estraneità che discende dal magistero dell’eccezionale Atget di Parigi. Le vedo immote e belle sulla nostra Treccani. Due immagini fra tutte quelle viste in queste foto e che saprei ridisegnare ad occhi chiusi: il tempietto bizantino di Portogruaro, la pieve romanica, con il campanile cilindrico poggiato su di un lato della facciata, dispersa nella campagna senese di Corsignano. E la Firenze che mi si ricostruisce è una città di pura fantasia, non è quella dell’anno di Lacerba 1913 né di quello dannunziano del 1907, è di un tempo incognito e indistinto, dove i fabbricati moderni di un luogo, che una memoria ricorda perché assimilati intemporalmente in ragione della loro armonia, possono semplicemente riproiettarsi a ritroso in un passato dal quale discendono. Approdo col treno e scendo ma dimentico subito quella “bojata” (lo disse Papini?) della Stazione Santa Maria Novella.
Una via fra alte case mi incammina verso il Canto del Gallo presso cui abitavano i Pavolini. Costeggio San Lorenzo, giro per la bella strada e vado verso nord. Bugnati grigi di palazzi si alternano a quel bianco intonaco delle case più modeste sul quale sorride il verde delle persiane. Il lastricato a larghe tessere rettangolari, diviene lucido a specchio se piove. Sbuco sulla circonvallazione. Una gran porta campeggia desolata nel mezzo d’un povero giardinetto affogato. Decaduta a spartitraffico delle file di automobili che si accalcano ai semafori della piazza. In fronte a me ho il Parterre. I cancelli sono aperti per lavori e io vi entro. D’un tratto sparisce anche il rumore del traffico. Tutto l’anfiteatro è in disordine con mucchi di sabbia e calcina disposti nella platea e impalcature smontate sui gradoni eppure nella solitudine se ne ammira la semplice bellezza. Da fuori il suo colore vivo arancio si compone al verde degli alberi della via appena limitrofa che fugge verso nord e soprattutto verso quel celeste indicibile del cielo d’Appennino. L’alto cielo spirituale di Campana. Fantastico oltre e immagino di percorrere una via che mi porti verso la collina.
Sono alle Cure? È bello il nome della località. Forse c’erano delle sorgenti d’acqua calda? Rammento che sono esistite, l’ho letto in un tomo vetusto, delle terme di Firenze. Proseguo, effettuo qualche svolta ma sono attratto da questo quartiere che si adagia sulla collina. Sembra di respirare un’aria di paese a un dipresso d’una città, una delle più belle del mondo. Trovo una quieta via che sale con appena un minimo di ripidità. Casette ridenti colle loro imposte verdi ai due lati. I portoncini ad arco. Che grazia, dappertutto è bella proporzione, e senso del bello nella più scarna semplicità. E prossimo appare sotto la volta celeste il verde della collina di Fiesole.
Non è raro che nella solitudine della mia camera, quando la pendola dell’orologio del Duomo già rintocca le ore piccole ponga mano alla matita e lasciati al pomeriggio gli ultimi scarabocchi mi dia a ritrascrivere delle frasi da autori che ammiro. Inseguo uno stile. Quale esso sia non posso però esprimere con precisione metrica. Se scrivo, ciò è in guisa, come queste linee, di promemoria. O di appunto. Lungo gli scaffali della biblioteca trovo le opere di Céline. Non sempre traggo per la veglia notturna i romanzi che sono molto lunghi. Piuttosto le lettere, gustose, furiose, dilettevolissime nel loro francese colloquiale. Appassionato come sono di aeroplanini di carta cui dare forme di veleggiatori marini mi ero dato anche ad un tentativo di censire i luoghi delle scritture celiniane ove apparissero quelle due belle parole che nella lingua di Francia denominano i gabbiani. Goéland e mouette. La prima tratta da un celtico gwelan, la seconda affine al tedesco Möwe.
Il primo il volatore dell’Atlantico, il secondo più acclimatato sui fiumi e, come dice il nome, più piccolo. Sfogliavo rapide le pagine di Mort à crédit dalle quali trascrivevo queste linee invero molto suggestive
Mais j’ai passé autrement d’heures à me fasciner des mouvements d’eaux…da tout le cache-cache des arches…l’autre arche!...le gros bateau-citerne…un autre!...le petit yacht!...une mouette!...deux!...la magie des bulles au courant…clapotis!
L’air, la mousse, l’helice, le roulis, l’énorme bouillon, tourbillon de bulles, c’etait tout de même un paradis!...et ” les mouettes maman!”bang!…
che qui cerco di voltare:
Ma ne ho ben trascorse io, di ore, a contemplar affascinato i moti dell’acqua…da tutto il via vai delle chiatte…eccone un'altra!... e la nave cisterna…un’altra!...ecco uno yacht minuscolo!...e un gabbiano!...due!...che magherìa le bolle d’aria nella corrente…lo sciabordìo!
E l’aria, la schiuma, le eliche, il mulinello, il gran bollore e turbinìo delle bolle, mi pareva d’esser in un paradiso!... e i gridi “mamma ecco i gabbiani!” bum!...
Corre la mente sulla Senna, quando il suo corso rallenta e le acque sentono che stanno per gettarsi nell’estuario di Le Havre e gli stanchi gabbiani si cullano al vento impetuoso tenendo le ali immobili. Senza fatica. Sospesi nell’aria. Anche di queste immagini lontane si nutriva la veglia notturna nella città posta sotto l’ombra del Säntis.
Il censimento dei goélands e delle mouettes si arrestava presto. Era una fatica improba scorrere tutte le pagine dei volumi céliniani raccolti negli scaffali alla cerca delle due graziose parole evocanti la nobile livrea grigia nera e candida dello slanciato veleggiatore marino e fluviale. Ma il proposito frustrato non lasciava soverchia traccia di sé. Sapevo che avrei incontrato la sera successiva in quella biblioteca nuove opere che avrebbero attirato la mia curiosità spegnendo le velleità passate. I taccuini dannunziani, i garbati pettegolezzi di Tom Antongini segretario dell’imprevedibile D’Annunzio, le belle novelle asiatiche del De Gobineau, perfino la Stereometria Doliorum di Keplero avrei portato nella mia camera. Sperimentavo la realtà insopprimibile della sentenza di Prezzolini: nella vita della cultura le biblioteche son più importanti delle scuole, cui associo con sommo diletto la massima lapidaria di Gomez Davila: cultura è tutto ciò che non può insegnare l’università. Un agguato bello e buono alla pompa delle accademie.
Non è raro che le notti dell’ultimo autunno approssimate ormai all’inverno, siano in questo lembo di Svizzera orientale ed alpina d’una bellezza quasi inverosimile. Nel silenzio delle ore piccole a volte uscivo dopo la lettura dalla camera per avviarmi alla salita del Rosenberg. Sbrigavo a passo rapido i pochi tornanti costellati sui lati dalle casette belle époque irte di pinnacoli e di quei balconcini semiottagonali e chiusi noti col nome di Erker. Nessun lume alle finestre e flebile la luce dei lampioni al risparmio, arrivavo presto a costeggiare il bosco di abeti che occulta sul lato destro dell’ultima salita l’università. Sul tratto pianeggiante si scoprivano i fabbricati in istile razionale della biblioteca e delle aule. Nell’oscurità notturna la piramide in cristallo che fa da tetto alla biblioteca lanciava qualche blando riverbero ai raggi della teoria di lampioni della via rettilinea che conduce allo slargo dell’orologio.
Imboccata la vietta che dall’orologio luminoso sale mi trovo rapidamente in aperta campagna. Sulle colline circostanti solo qualche luce presso i casolari. Le cime arboree oscillano ai brevi colpi di vento sui prati oscurati dal manto notturno. Lontano si intuisce la massa oscura del Säntis e ad essa opposta, alla mia sinistra sulla strada di campagna che prosegue verso oriente, la valle ondulata che digrada al lago di Costanza. Le fronde più lievi d’un albero a ridosso del lampione solitario, agitate dagli aliti di vento, proiettano sull’asfalto della strada delle ombre mobili. I raggi di luce del lampione permettono di riconoscere alle imposte dell’ultima casa poco più il là le belle campiture triangolari della decorazione, bianca e rossa e separata, già nel mezzo del prato, la vasca di abbevero delle bestie. È silenzio assoluto. Trascrivo da Gomez Davila: ad un Dio come postulato dell’etica preferisco un Dio che postuli l’estetica perchè la bellezza dell’inesplicabile spettacolo sotto il cielo stellato mi conferma che la postulazione estetica cui si riferisce questa massima è continua e inesauribile.
Poscritto
Dopo qualche linea arrestavo la lettura della Stereometria Doliorum di Keplero. Il latino scientifico e le cognizioni richieste nell’arzigogolata scrittura del tempo chiedevano troppo sforzo. L’opera era costellata di intricate illustrazioni. Ma sorrido nel pensare che questo scritto del grande matematico e astronomo possa applicarsi alla donna di quel secolo. Keplero aveva composto l’opera per dare un metodo di misura pel volume delle botti della sua epoca, di generose dimensioni ma di geometrie non così ideali come quelle dei solidi che impariamo a scuola. Il ricordo corre ai “tedeschi lurchi” di Dante, sempre intenti allora come oggi a sbocconcellare pietanze, e qui uso un termine delicato, e a bere. Vini e birre, birre e vini.
Non mi stupisco della singolare richiesta posta al matematico delle traiettorie planetarie: a chi si inebria della visione del cielo stellato e ha grande dottrina deve rivolgersi chi vuol mettere un fondamento razionale all’inesauribilità del calice ben pieno di bevanda cordiale… Ma, e torno alla questione femminile, se rammento la storia dei due matrimoni di Keplero e della conseguente numerosa nidiata di infanti avuta dalle due mogli, mi vien quasi da pensare che la misura del volume di carico delle botti possa anche applicarsi per prevedere il carico di infanti che una futura moglie può generare… Nell’opera Latte d’autunno, scritta dall’autrice popolare Anna Wimschneider, una donna della campagna bavarese che fin da bambina lavorò duramente nei campi, appare ad un certo punto delle memorie una donna che al prete che le rimproverava di sottrarsi al suo dovere di generatrice rispondeva di non essere un forno per pani. Anche questa risposta rende il senso lato della Stereometria, letteralmente misura di volumi.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
Cultura
Violetta Valéry ritorna nel suo tempo: una Traviata ottocentesca per il Maggio Musicale
Firenze: una Butterfly d'eccezione per il centenario pucciniano
Madama Butterfly tra Oriente e Occidente: Daniele Gatti legge il capolavoro di Puccini
Una favola che seduce e incanta: Cenerentola di Rossini trionfa al Maggio
Un lampo, un sogno, un gioco: Gioacchino Rossini, Manu Lalli e l'incanto di Cenerentola