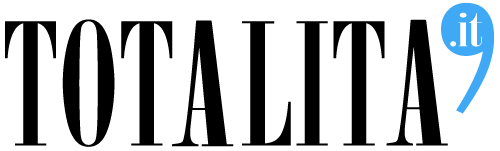Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Riflessioni dolorose
Ha senso continuare a scrivere poesia?
Lo spread e la finanza rendono impraticabile la bellezza e allora il poeta...
di Giovanni F. Accolla

Scrivo poesie più o meno da sempre, pur sembrandomi - e non da oggi - una attività del tutto inutile. Però, fatto strano, io che sono un autentico campione di pigrizia, non solo mi balocco, ma mi misuro con gran lena con questa attività che reputo anche piuttosto faticosa. Inutile, dunque, e faticosa.
Passando, dall’esperienza personale ad una riflessione più generale, c‘è più di qualcosa che non fila, che rimane incomprensibile tanto sul motivo per il quale oggi si scrivono versi, tanto sull’utilità stessa della poesia. Tolta quella porzione, pur non minoritaria, di poeti della spudorata “certificazione dell’esistenza in vita”, il cui propulsore psichico è senza dubbio un misto di nevrosi, frustrazione e vanità; che senso ha, ancora, star lì a contare settenari ed endecasillabi, a lambiccarsi i neuroni tra rime e allitterazioni? Mistero. Mi sembra che sia un arcano che seppur svelato singolarmente (coloro che scrivono possono pur spiegare le loro convincenti ragioni), non risolve l’enigma generale.
Al di la della ben nota sentenza di Adorno per la quale “scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie”, alla quale più mestamente aggiungerei: che senso ha dopo che si è letto Paul Celan (tanto per stare strettamente nel nesso) ovvero: lascia perdere che non ci puoi arrivare, fai altro; avrei proprio voglia di capire quale sia la molla o le molle che spingono ancora oggi delle persone colte, intelligenti e anche culturalmente smaliziate (scusate se mi metto in tale novero) a scrivere e - fatto sensibilmente ancor più grave - pubblicare versi.
Questo di oggi non è neanche più il “tempo della povertà” citato da Holderlin, su cui mirabilmente ha ragionato Heiddeger, ma è il tempo dell’indigenza, della povertà cronicizzata. E se per il filosofo il dovere dei poeti in quel momento era “poetare espressamente l’essenza stessa della poesia”, ora, seguendo questa logica al tempo autorevole, veritiera (e che ha dato tanti abbondanti e succosi frutti), a me sembra che l’obbligo dei poeti dovrebbe essere quello di tacere piuttosto che, unica prospettiva rimasta, lamentarsi o spacciare la raffigurazione di un personale scampolo di mondo per il mondo intero.
Addio “festa dell’intelletto”, evocata da Valery, oramai, per la maggior parte della produzione poetica odierna, rimane la parodia se non la farsa dell’ingegno. E purtroppo la gran parte delle raccolte pubblicate, almeno nell’ ultimo decennio, mi pare non smentiscano questa mia sensazione.
Bell’ipocrita - mi si dirà - dici queste cose, le scrivi perfino, e ciò nonostante… sì, scrivo poesie, e seppur un po’ vergognandomene, le pubblico. È un meccanismo di causa-effetto, ovviamente fine a se stesso. Sapete perché scrivo poesie? Per vivere meglio. Perché anche il nulla in cui sono sprofondato esige una forma. E grazie a questa forma organizzo il fortino della mia personale resistenza. Scrivo per vivere meglio, o meglio, per non uscire dalla vita che conta per davvero, quella in cui io è più forte del destino. Per il resto, quanto appare non necessariamente è, al massimo esiste.
Come la cattiva poesia che probabilmente faccio, ma che provo a riscattare in quella buona che leggo continuamente, che cerco di capire e memorizzare per averla a portata di mano, come un farmaco salvavita, nei momenti più difficili o magari soltanto per riempire i vuoti, per ammazzare il tempo - come si dice - nel traffico cittadino. Perché il tempo della buona poesia è tempo redento dai detriti della storia, si svolge fuori dal continuum cronologico che tutto corrompe e consuma.
Il poeta consapevole, oggi sa di essere il nulla creatore del suo nulla e comprende di consegnare al mondo contemporaneo soltanto, e nella migliore delle ipotesi, il suo disagio. Perché non è più il suo tempo e non c’è più tempo.
La poesia può essere, tutt’al più, un frammento ben fatto di un corpo che non esiste, o un foro sulla tela dell’apparire, uno squarcio attraverso il quale s’avverte la vertigine di prospettive incomprensibili, inconciliabili con la vita o il sibilo assordante dell’oblio.
C’è poco altro da dire: questo è il nostro tempo, quello che ci è stato dato in sorte da vivere o da trascorrere, secondo i gusti e le attitudini. E non c’è giudizio, nessuno può più giudicare per davvero, se non ricorrendo ad espedienti intellettuali quasi sempre poco onesti che hanno a che fare con la relatività, con l’occasione e l’ estemporaneità. Il valore assoluto sembra oramai perduto per sempre, e meno male: moriremmo tutti dalla vergogna.
.