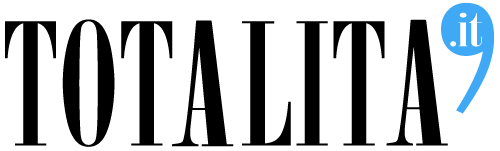Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Il maresciallo Radetzky
Tempo di febbraio
Ho scarabocchiato la marziale architettura prima ancora di giungere alla stazione di Montebello
di Piccolo da Chioggia

Colli Berici
Alla stazione nella periferia veronese il treno arriva vuoto e in orario per le quattordici e quarantasette di questo nuvoloso pomeriggio di febbraio. Quasi nessuno attende il convoglio e io, salito, posso scegliere un posto sul versante che lungo la via di Padova è quello meridionale, leggermente più luminoso in ragione del corso d’un sole che a tratti si intravede fra gli spessi vapori delle nubi. Queste indistintamente oscillano nel loro color grigio da una punta dorata ad un filo di rosa nel fondo, dove la pianura allontanata va a confinare con il cielo. Ripercorro all’inverso la strada ferrata che un dì del luglio 1849 vedeva il primo convoglio giungere a Verona da Vicenza. Auspice, così è scritto nelle cronache, era il maresciallo Radetzky, passato nella sua interminabile carriera d’armi, dalle cavalcate sui campi dell’Europa squassata da Napoleone ai viaggi “per Bahn”, su traballanti carrozze al traino delle locomotive a vapore. Se ci si pensa, questa dev’essere stata una scossa non comune all’appercezione del panorama. Prima affrontato sulla sella d’un bucefalo docile o capriccioso, ora subìto seduti in una piccola cella mobile. Per quanto la velocità del transito lungo la piana che da Verona porta a Vicenza sia incomparabilmente superiore alla sbuffante locomotiva di allora, ci si accorge delle vibrazioni che sono un’evoluzione evidente del traballare dei carrelli d’un tempo. La distesa dei campi è bella: il clima di pioggia di questi giorni ha ravvivato fino alla luminosità il verde dell’erba e il bruno del suolo è corposo e alternato a seconda dei poderi e delle relative lavorazioni e attese, e varia da toni forti di nero a castano rossiccio.
Qua e là un fiumiciattolo traversa il transito del treno luccicando dal di sotto del livello delle rotaie, e brillano le acque correnti fra il celeste e il verde misti ad un color panna. In un effetto quasi fosforescente. Questa volta mi sono ricordato di portare, assieme ad una microscopica matita, pure una lunga striscia di carta, strappata da un rotolo di quelli che si usano nei registratori di cassa e ripiegata a fisarmonica. La uso per annotare a scarabocchi ciò che vedo. Imparo o tento almeno di abituarmi all’uso di prendere appunti proprio quando non sono necessari a nessun fine esplicito. Un esercizio non del tutto dissennato. I primi segni li traccio osservando le prime nubi che lontano sulla linea che separa pianura e cielo, si incuneano l’una nell’altra con diverse tinte. Il primo scarabocchio è una linea spezzata che raffigura gli ultimi termini raggiunti dal vedere: alberi lontanissimi sul fondo, sagome indistinte fra loro di tetti, qualche torretta, forse solo un fabbricato più alto. Delle linee prospettiche convergenti verso un punto di fondo per fingere profondità e rammentare le mutue demarcazioni dei campi. Sovrastanti due nuvole e indicazioni di colore: una punta di rosa sul grigio, bianco vivo per il disco solare che si intravede nettissimo come una luna diurna velata da vapori di nubi. Il treno corre ben più rapido della vetusta locomotiva di Radetzky, un rivo è sorpassato di fretta: scorgo solo il verde fosforescente delle acque e lo annoto fra le due linee oblique che figurano il letto del fiumiciattolo ed il ponticello che vi disegno a collegamento. Color bruno vivo del suolo delle rive spoglie di qualsiasi arbusto. Lo sguardo incontra presto i colli Berici che declinano verso il meridione della pianura. Ne traccio la linea come la vedo, digradante a destra per sparire nel tratto piano. Alture celesti e grigie con una sfumatura di viola, sotto il cielo nuvoloso. Scrivo un appunto inutile: verso Est.
Il panorama dei colli che si avvicinano mi rammenta l’immagine medievale d’un castello intravisto sulla coperta d’un volume giusto alcune ore prima di partire. Irto di torri che terminano in coni, le mura merlate, tre costruzioni interne colle finestre in bell’ordine, i tetti a piramide dagli spioventi ripidi e una porta d’accesso con scala. Ho scarabocchiato la marziale architettura prima ancora di giungere alla stazione di Montebello. E sullo sfondo vi ho riportato il crinale dei colli che vedo arrivare: infatti siedo rivolto a oriente. Ho disegnato il castello semplicemente perché volevo ricordare i colori del bel disegno medievale: tinta di sabbia dorata tutte le mura, ruggine vivo tutti i tetti ed il suolo. Il cielo blu in alto che digrada in bianco sulle colline grigio celesti. Così annotavo sulla striscia di carta che diviene man mano un filmato manuale di impressioni calate in figurine e parole. Queste ultime composte solo in constatazioni ellittiche, formate di sostantivi e degli aggettivi ad essi riferiti. Nessun verbo come mi accorgo nella rilettura. Una conseguenza possibile, dato che il verbo indica azione, del fatto che le percezioni sono subite passivamente durante il viaggio nella cellula del vagone. Lo scarabocchio che deve ritrarre il castello è quasi riuscito pur con la mano resa malferma dalle scosse della carrozza. Non per questo, adattando al mio caso la sprezzante burla di Schiller a certi poeti, mi crederò certo un disegnatore. Alla fermata di Montebello inizio a volgere lo sguardo anche a settentrione: le valli del Chiampo e dell’Agno si aprono, i Berici sono prossimi e su di essi si cominciano a distinguere gli agglomerati di case e i boschi. Annoto il contrasto di colori del fabbricato della stazioncina di campagna: giallo vivo il muro, ruggine molto scura per le tegole del tetto. Cielo sempre grigio celeste. Scarabocchio pure la siluetta d’un albero che ombreggia uno stagno e a lato scrivo: marrone, argento. Imboccata la strettoia di Montecchio Maggiore l’unico sguardo possibile nel panorama devastato dalle costruzioni disordinate è sulla collina berica che si costeggia in un lungo rettilineo. Fermo in stazione a Vicenza osservo una locomotiva a vapore immota sui binari periferici proprio sotto l’incombente collina del santuario. Mi appare come un’architettura mobile dove ogni linea, ogni strumento sono disegnati e costruiti solo in base all’ufficio meccanico che devono svolgere. Se qualsiasi intento estetico pare bandito, pure la macchina in sé è armoniosa. Resto sempre solo su questo convoglio stranamente sguarnito di viaggiatori.
Ripartito, il treno passa in un alveo dal quale si intravede in alto il profilo dell’arco palladiano “delle scalette” che inaugura una salita verso il santuario. In un lampo, appena qualche decina di metri prima dell’arco e prima della galleria che il treno deve transitare prima di uscire sul lato berico della gloriosa “Rotonda”, quello rivolto verso Padova, annoto mentalmente uno strano albero cui sono stati troncati tutti i rami e si leva come un allampanato traliccio irto di bracci nudi. Volti in tutte le direzioni. Lo scarabocchio non appena esco dalla breve galleria perché mi possa tornare utile quando volessi costruire un’altra delle mie strutture con i lari ad ali estese. Sulla pianura oltre Vicenza ci si sente immersi entro il panorama magnifico, quello palladiano, vegliato alle spalle settentrionali dall’Altipiano di Asiago e dal massiccio del Grappa. Sempre volgo lo sguardo alla pianura a mezzogiorno, racchiusa come in un anfiteatro dai Colli Berici e da quelli Euganei. Ma non traccio più quelle stilizzazioni astratte di questo paesaggio colle quali ho riempito fogli e foglietti nei viaggi passati. Alla più riuscita di esse avevo dato un titolo: “forma ed evento”, omaggio a Carlo Diano. Era avvenuto, che avessi visto su questo anfiteatro in un pomeriggio piovoso e ancora dal treno, la scarica d’un fulmine illuminare delle pallide nubi di color grigio e bruno e la bellezza dello spettacolo mi era rimasta impressa. La striscia è ristretta e ora posso solo scarabocchiare le siluette degli alberi potati, col grosso tronco mozzato ai primi rami, dai quali si dipartono gli steli filiformi che diventeranno rami nel tempo. Guareschi ha disegnato questi alberi potati nelle sue vignette con un risultato espressivo sorprendente. Ha condensato così, nei pochi tratti vigorosi di queste sentinelle arboree, la poesia della pianura padana della quale questo tratto ferrato fra Adige e Brenta è il golfo settentrionale ed orientale.
In quel di Padova, all’arrivo in stazione ripongo strisciolina di carta e matita. Solo ad un certo punto, nella piazza dell’Accademia Delia, sotto l’ombra della massiva torre carrarese mi incuriosisco davanti la vetrina d’un corniciaio e prendo un appunto figurato: fa strana mostra di sé un quadretto astratto. Le forme casuali pennellate in grigio, nero, rosso e bianco. danno la netta suggestione di raffigurare una spiaggia notturna. Più tardi, ed è calata la sera, alla luce dei lampioni, arrivo al capo finale della strisciolina e vi scarabocchio una struttura a traliccio che ai suoi bracci non reca gli isolatori che reggono le lunghe catenarie dei cavi elettrici distesi da un traliccio all’altro ma alberga due lari ad ali aperte. E poi schizzo un vaso arzigogolato e panciuto con un solo fiore. Quali siano state le associazioni mentali o le impressioni di cose viste a propiziarmi questi ultimi rudimenti d’immagini non riesco a rammentare. Nemmeno quando, nella mia camera, ho ripassato, come faceva il favoliere Andersen nelle cartoline da lui disegnate nel viaggio in Italia del 1835, i segni flebili del lapis con la china. Plausibilmente è stata solo la disarmonia del vedere l’ultimo lembo bianco sulla strisciolina. Quasi quella d’un racconto o d’un film senza conclusione.
Poscritto
La prima delle stilizzazioni di omaggio all’ellenista di “forma ed evento” l’avevo tracciata con una piuma remigante di gabbiano trovata sul litorale di Adria. Come il solito, mi avviene che rare volte le vie, lungo le quali muovo, siano rettilinee. Conservo una copia di questo omaggio e osservo che il paesaggio stilizzato si presenta piuttosto come una selva di torri e case. Una San Gimignano resa astratta e ridotta all’osso. Quelli successivi, i più riusciti, erano effettivamente calcati sull’impressione prospettica del breve paesaggio che separa i colli Berici dagli Euganei. Per giustificare una volontà di dedicare l’astratta selva di torri che mi era nata di getto sulle riflessioni propiziate dalla brillante endiadi “forma ed evento” vi avevo scarabocchiato, intingendo a fondo il calamo della piuma nell’inchiostro, il fulmine che diverrà motivo consueto nelle successive stilizzazioni. Il lampo, l’esplosione d’una linea spezzata e luminosa , che illumina ad esemplificare l’”evento”, lo“id quod cuique evenit hic et nunc”. Torri e case che identificavo come esempi della “forma”, in virtù dell’impianto riducibile a figure elementari come rettangoli, triangoli e cerchi, connaturale ad ogni architettura fin dai rudimenti. In allegoria si potrebbe anche vedere nel quadretto come le forme, che esistono di per sé, una volta avviate sulla loro traiettoria dalle di loro cause, vengano rischiarate ovvero trasfigurate dall’evento e quindi ad esso si possano unire, non fosse che per un solo istante, a comporre una superiore unità. Noi vediamo il panorama dei tetti e delle torri, dunque delle forme, nel pomeriggio piovoso. All’improvviso nel balenare del lampo noi le vediamo trasfigurate nella luce abbagliante data loro dalla scarica ed in quell’istante ne avvertiamo un’altra, superiore bellezza. I loro contorni si fanno infatti nitidissimi e i colori permangono ma sono sfumati dall’argento lampante della luce.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
Cultura
Violetta Valéry ritorna nel suo tempo: una Traviata ottocentesca per il Maggio Musicale
Firenze: una Butterfly d'eccezione per il centenario pucciniano
Madama Butterfly tra Oriente e Occidente: Daniele Gatti legge il capolavoro di Puccini
Una favola che seduce e incanta: Cenerentola di Rossini trionfa al Maggio
Un lampo, un sogno, un gioco: Gioacchino Rossini, Manu Lalli e l'incanto di Cenerentola