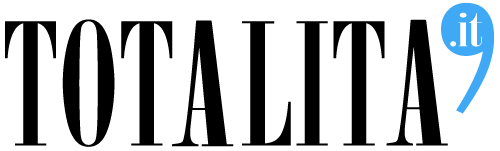Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Il compito di una scuola calcio
Il calcio è dei giovani
Ci sono due tipi di comunicazione che si presentano all’interno di un ambiente sportivo: quella primaria e quella più avanzata
di Tommaso Nuti

Come può un bambino appassionarsi a quello che dovrebbe essere un gioco quando viene “relegato” nella squadra “B” della sua società perché considerato fisicamente o tecnicamente indietro rispetto ad altri compagni? Con quale tipo di autorità può un istruttore (spesso e volentieri senza neanche una qualche forma di patentino alla mano) distinguere due squadre di bambini dall’età da 6 a 9 anni secondo “valori tecnici”?
Il compito di una scuola calcio è fondamentale nella formazione psicologica e fisica di un bambino. Fin dalla scuola elementare si attesta un minimo impegno degli insegnanti nel far partecipare alle lezioni di educazione fisica i piccoli studenti, senza grandi risultati; in realtà, quello dell’istruttore di una scuola calcio è un compito ben più preciso: il suo obiettivo è formare le basi per un futuro uomo che né famiglia né scuola possono toccare; certamente sono molto importanti queste due sfere sociali, ma quelli sportivi sono singoli aspetti comportamentali ed educativi che vanno oltre ciò che viene trattato in classe o affrontato coi genitori. Se da una parte si impara a leggere e fare operazioni matematiche o svolgere dei piccoli compiti in casa, dall’altra si impara a stare in un gruppo di coetanei, a rapportarsi con persone più grandi come un allenatore e ad avere rispetto per persone che ogni settimana si incontrano.
Innanzitutto però non si dovrebbe educare i ragazzi, ma gli educatori: si devono formare istruttori, non allenatori.
La maggior parte dei ragazzi (80% circa) giunti in età post-puberale abbandonano lo sport, quando verso l’età di 13-14 anni la pratica di uno sport è essenziale nella formazione sociale e fisica di un ragazzo. Allora come mai?
Il fenomeno viene definito “drop out” e si concentra su risultati, agonismi esasperati, interessi economici e genitori invasivi.
Fin dall’inizio i bambini sono sottoposti a pressioni e responsabilità che anno dopo anno diventano sempre più importanti. Nel calcio di oggi conta meno sapersi divertire, saper toccare il pallone, sapersi muovere in campo: conta solo vincere; a tal proposito Zvonimir Boban, ex giocatore del Milan, ora opinionista di Sky Sport dice che il calcio è prigioniero della tattica.
Le varie società dilettantistiche (e qualche volta anche quelle professionistiche) si impegnano solo a far crescere dentro i giovani giocatori la competitività; sicuramente è un aspetto importantissimo, mettersi in gioco di fronte a situazioni spesso difficili è un piccolo passo parallelo a ciò che verrà affrontato nella vita di ciascuno di loro. Purtroppo però la figura del mister continua in molte situazioni a involversi.
Maurizio Mondoni, docente di Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi al Corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sostiene che per capire il perché un ragazzo improvvisamente lascia un’attività sportiva che ha praticato per anni è necessario comprendere quali sono le molle iniziali che gli hanno fatto decidere di intraprenderla. E tra queste su tutte il divertimento, la gioia di giocare, di fare parte di un gruppo, conoscere nuovi amici. Se i giovani non trovano soddisfatti questi loro bisogni primari, lasciano.
Quando si parla di bambini, non si può pensare al risultato, al ritmo, alla tecnica; è già dagli allenamenti che si impara a maturare quegli aspetti che se non sufficientemente considerati porteranno a smettere di praticare sport. Ci sono vari cosiddetti “istruttori” che si preoccupano solo di preparare un bambino (e si parla dell’età di 6-9 anni)a vincere, a pensare a ciò che deve fare per contrastare lo “avversario”, quando si dovrebbe pensare a procurare un bagaglio di esperienze vissute in campo che possono porre delle basi tecniche e psicologiche. Un allenatore non deve essere una figura che trasmette regole da prendere in modo dogmatico, deve sapersi mettere in discussione, deve saper comunicare e trasmettere in maniera verbale le proprie idee di gioco e di divertimento: insomma, il suo modo di pensare deve essere articolato in base ai giocatori che si trova di fronte, dai più piccoli ai più grandi.
Fondamentale nell’apprendimento tecnico di un giocatore è il linguaggio. Ci sono due tipi di comunicazione che si presentano all’interno di un ambiente sportivo: quella primaria e quella più avanzata. La capacità espressiva dell’allenatore si evolve con il passare degli anni passando da suggerimenti che potrebbero essere paragonabili ad una storia fino ad arrivare a semplificazioni puramente tecniche.
Nei primi anni di attività un bambino relaziona gli insegnamenti dell’istruttore al linguaggio di un mondo esterno e conosciuto lontanamente, quasi intoccabile, come potrebbe essere quello delle fiabe o delle favole: è più facile così instaurare una piccola conversazione con un giovane, in base a termini lunghi ed articolati, come se fosse una vera e propria storia che può essere percepita chiaramente. Grazie a questo metodo l’allenatore riesce a far visualizzare a un piccolo giocatore un’immagine di gioco ben definita, che potrà apprendere facilmente.
Con il passare degli anni il metodo comunicativo cambia e diventa sempre meno dettagliato. L’allenatore si concentra su parole chiave che da un ambiente esterno possono essere percepite come incomprensibili o difficili; grazie ad una chiave di lettura però possono essere apprese e comprese dai giocatori che, se riescono ad applicarle in campo – e questo passaggio è fondamentale – viene facilitata la percezione dei suggerimenti dell’allenatore o di un compagno di squadra. Così, se in partita un giocatore è immerso in una situazione di urla, tensione o stanchezza, bastano poche parole, semplici ed immediatamente comprensibili per poter comunicare direttamente con qualcuno, senza bisogno di parlare, correggere o prolungare il dialogo, adattandosi alla velocità di azione richiesta dal gioco.
In altre parole, saper comunicare con i propri giocatori è molto importante per la loro crescita e maturazione.
Tornando al calcio giovanile però, ciò che è ben visibile nei vari vivai delle società di tutta Italia è che il bambino non è più abituato al divertimento. Non si fanno crescere i giovani, ma si fanno gareggiare.
Massimo De Paoli, ex allenatore delle giovanili di Brescia ed Inter e laureato in Architettura, sostiene che il compito di un allenatore non è vincere un campionato delle categorie Giovanissimi o Allievi, ma abituare il ragazzo stesso a giocare. Perché un giocatore è come uno scalatore, dove l’aria è buona è facile respirare è semplice poter emergere, ma continuando a scalare – e quindi ad aumentare in categorie sempre più vicine al professionismo – l’ossigeno non è più buono e puro come lo era a valle; la scalata comincerà ad essere sempre più dura e se non hanno la maschera d’ossigeno – l’equivalente delle basi tecniche e morali – devono tornare indietro e sarà tutto inutile.
Il calcio non è più dei giovani, ma dovrebbe tornare ad esserlo, senza genitori che spingono il figlio ad essere ciò che loro vorrebbero (spesso e volentieri tramite imprecazioni di vario genere e risse sugli spalti), senza finti educatori o piccoli ed inutili allenatori concentrati a vincere categorie inutili non preoccupandosi di formare il bagaglio di un ragazzo, senza società focalizzate sul guadagno, senza procuratori che scorrazzano giocatori per centinaia di chilometri inutilmente in tutta Italia lontani da quella che dovrebbe essere la loro vera vita, senza tutto ciò che è in contrasto con l’aspetto più vero del calcio, il divertimento, la serenità del gioco. Nasce tutto da lì, dai sogni di un bambino che calcia un pallone pensando a chi potrebbe o vorrebbe diventare. Magari, inconsapevolmente, un calcio al mondo che lo circonda e a cui non dovrebbe appartenere.