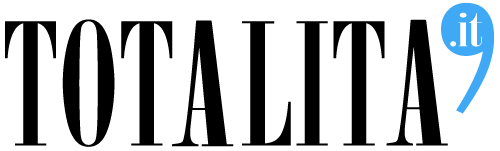Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
Editoriale
La legge di stabilità prelude alla instabilità futura. E se si cambiasse sistema?
Troppe tasse e troppi prestiti il sistema sbagliato che non fa crescere l'Italia

di Marco Di Eugenio
 iorni di legge di stabilità in Parlamento. Tempo fa,
leggendo una bozza, la Commissione Europea l’ha giudicata “a rischio di mancato
rispetto del patto di stabilità e crescita”. Vedremo. L’impressione, insomma, è
di essere alle solite: conti italiani traballanti e crescita con lo zero
davanti. Soprattutto, tagli alla spesa pubblica annunciati, ma non realizzati. L’occasione,
allora, è buona per una breve ricostruzione del debito pubblico e dei mali dell’economia
italiana.
iorni di legge di stabilità in Parlamento. Tempo fa,
leggendo una bozza, la Commissione Europea l’ha giudicata “a rischio di mancato
rispetto del patto di stabilità e crescita”. Vedremo. L’impressione, insomma, è
di essere alle solite: conti italiani traballanti e crescita con lo zero
davanti. Soprattutto, tagli alla spesa pubblica annunciati, ma non realizzati. L’occasione,
allora, è buona per una breve ricostruzione del debito pubblico e dei mali dell’economia
italiana.
Partiamo col dire che uno Stato ha tre modi per finanziarsi: a) inflazione, b) tasse e c) prestiti. La forma di finanziamento preferita dai governi italiani della prima repubblica è stata la prima. In altre parole, negli anni del dopoguerra lo stato italiano stampa moneta. Lo fa in maniera controllata perché tutto sommato non c’è bisogno di troppi soldi: la crescita costante del pil, il boom delle nascite e la diminuzione della popolazione anziana decimata dalla guerra rendono il sistema pensionistico statale sostenibile (molti lavoratori mantengono pochi pensionati) e quello sanitario efficiente.
Con gli anni Settanta, però, le cose cambiano. Per poter sopportare le politiche sociali (spesso clientelari e improduttive) avviate proprio in quegli anni e una macchina burocratica sempre più estesa (nel ’70 vennero istituite le Regioni), i governi italiani hanno bisogno di risorse. Così, iniziano a stampare più moneta tramite la Banca Centrale. Tutto facile? Non proprio. Se così fosse, per combattere disoccupazione e povertà sarebbe sufficiente (per usare una metafora del premio Nobel Milton Friedman) riempire un elicottero di banconote e poi distribuirle dal cielo. Ugo Tognazzi diceva: “Inflazione significa essere povero con tanti soldi in tasca.” E aveva ragione!
Dopo un decennio di scellerata politica di accrescimento della massa monetaria senza un corrispettivo aumento di beni e servizi, gli italiani si ritrovano a fine anni settanta con prezzi che aumentano anche del 20% ogni anno, risparmi svalutati e una moneta che perde continuamente potere d’acquisto. Risultato: crisi economica e crescenti tensioni sociali. Si pone rimedio alle politiche inflattive con la privatizzazione di Bankitalia nel 1981 da parte del Ministro Andreatta. In pratica, Bankitalia non è più obbligata a comprare i titoli emessi dallo stato italiano. Ma l’Italia non è la sola a svalutare la moneta. Molti paesi, compresa l’Inghilterra pre Thatcher che nel frattempo ha abbracciato le ricette laburiste, lo fanno. Per porre un freno viene introdotto lo SME e a seguire il sistema euro.
Con l’introduzione della nuova moneta, come sappiamo, viene vietato alla Banca Centrale di acquistare titoli di stato, e quindi finanziare il debito. Un male? Assolutamente no. Prima ancora dell’Europa dei parametri e dei vincoli discutibili, infatti, il problema sono gli stessi singoli paesi. Alcuni fanno i furbi. Lo Stato italiano, ad esempio, non ha intenzione di mettersi a dieta. Non potendo più stampare moneta, intensifica il ricorso alle altre due forme di finanziamento: le tasse e i prestiti. Con risultanti anche in questo caso drammatici. La pressione fiscale, che era stata del 25% pil nel periodo 1965-1980 e del 34,78% nel periodo 1981-1993, sale fino all’attuale 43% (ma la «pressione fiscale effettiva», che non comprende l’economia sommersa, secondo la Fondazione dei Dottori Commercialisti sarebbe del 52,2%), mentre Il debito pubblico giunge dal 56% del pil del 1980 agli oltre 130% attuali. Il ricorso al prestito, peraltro facilitato dagli interessi più bassi da pagare grazie alla forza dell’euro, piace ai politici perché rispetto alla tassazione non crea malcontento. Ma nasconde un’insidia pericolosa: scarica sulle future generazioni i costi delle inefficienze e degli sprechi della politica. Oggi ne paghiamo il conto.
Chi presta i soldi allo stato italiano? Fondi d’investimento, banche, ma anche e soprattutto famiglie italiane. In pratica, un giro perverso nel quale genitori investono i propri risparmi in titoli statali, alimentando il mostro della spesa pubblica che a sua volta divora i propri figli. Ma c’è di più. La propensione al prestito degli italiani ha creato danni anche all’economia e ai privati. Vediamo di chiarire. Il privato può finanziarsi con capitale di debito o capitale di rischio. Nel primo caso la somma di denaro viene prestata dall’investitore a un’azienda che dovrà restituire il capitale con l’aggiunta di un interesse fisso o variabile. Nel secondo caso, l’investitore acquista una quota della società (le azioni) e ne diventa socio. Facile intuire che questo secondo tipo di finanziamento è preferibile per un’azienda, che senza scadenze e obblighi di restituzione, può investire i capitali creando crescita aziendale e posti di lavoro.
Altrettanto facile intuire che, in Italia, le famiglie hanno preferito il prestito del primo modello. Il contrario di quanto avvenuto nei paesi anglosassoni, dove l’azionariato diffuso genera crescita di aziende (piccolo non è sempre bello…), posti di lavoro e spesso ricavi sostanziosi.
Del gigantismo statale e del nanismo industriale è anche colpa nostra. Se non cambia anche la società civile rispetto a certi temi, difficile aspettarsi qualcosa di buono dall’ennesima legge di stabilità ottimistica nelle previsioni e pessimistica nei risultati.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
il Banditore
Non possiamo nn dirci conservatori, e allora attenti con la santificazione della tecnologia
Quel che la Corte Suprema non ha considerando riguardo al divorzio
Perché la destra sta sparendo dall'agone politico
Mettete la museruola ai genitori incoscienti
Se le donne vincono quando in politica i migliori rinunciano