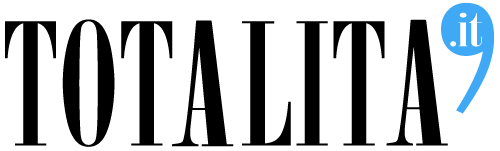Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Fosco Maraini
La sua ultima intervista del 22 gennaio 2004
Oltre che insigne studioso fu alpinista, fotografo, viaggiatore, esploratore, osservatore...di cui ricorre quest'anno il sesto anniversario della scomparsa
di Stefano Tesi

Fosco Maraini
Ricorre quest’anno il sesto anniversario della scomparsa di Fosco Maraini: oltre che insigne studioso fu alpinista, fotografo, viaggiatore, esploratore, osservatore acutissimo, commentatore scanzonato e poeta. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di esserne amico. È a me che concesse una delle ultime, forse l’ultima intervista in assoluto, pochi mesi prima della morte, risale al 22 gennaio 2004. La ripubblico qui in suo onore e a sua memoria.
La memoria di Fosco Maraini non lascia scampo: anticipa una per una, con una puntualità che sembra calibrata ad arte, le didascalie incollate alle foto della sua collezione. Anno, luogo, circostanze, compagni d’avventura. La mente scivola sui ricordi accarezzandoli delicatamente, con disincanto e appena un velo di asciutta nostalgia. A novant’anni suonati, Maraini è un’icona. Abbarbicato come un lichene alla sua dimora fiorentina sul Poggio Imperiale, acquistata dal nonno dove una volta sorgevano i poderi della “tenuta suburbana” dei sovrani lorenesi, si rammarica di non riuscire, per mancanza di tempo, a concludere un paio di progetti letterari in avanzato stato di elaborazione: il seguito del romanzo autobiografico Case, amori, universi (che si ferma al 1946) e un volume sulle “convergenze parallele” di Firenze e Kyoto, ovvero tra la sua città natale e quella adottiva.
Classe 1912, l’anziano professore ha navigato attraverso tutte le genti e tutte le epoche del cosiddetto secolo breve. Ha visto il mondo mutare profondamente. E si è preoccupato di garantire che i frutti di questo lungo viaggio – cioè il suo archivio e una biblioteca di 10mila volumi, quasi tutti dedicati alle civiltà orientali – non andassero perduti, conferendoli al Gabinetto Vieusseux.
Perché questa donazione e perché proprio al Vieusseux?
Innanzitutto non ho donato nulla a nessuno. L’ho venduto, nel 1996. E mica per soldi. Volevo solo essere sicuro che i miei libri e le mie carte non venissero dispersi o abbandonati in qualche sottoscala, dove troppe volte ho visto finire i fondi di qualche illustre collega. Che malinconia e che peccato sarebbe. Così ho pensato al Gabinetto Vieusseux, dove non solo mi hanno garantito con tutti i crismi legali che il nucleo non sarebbe mai stato smembrato, ma anche che sarà valorizzato, reso consultabile e magari integrato. È un accordo del quale sono molto soddisfatto. E che prevede che, finché sarò in vita, tutto resti dov’è, a casa mia.
C’è qualche volume da cui non si separerebbe mai?
Premesso che sono uno studioso, e non un collezionista, me ne vengono in mente due. Uno è un volume illustrato pubblicato in Giappone alla fine dell’800 per spiegare ai giapponesi l’epopea napoleonica. Una testimonianza straordinaria: l’imperatore e Giuseppina raffigurati nel modo in cui allora, nel paese del Sol Levante, vedevano noi europei. Un altro è l’”Atlantis Japanensis”, opera monumentale di Arnoldus Montanus tradotta in inglese da latino e pubblicata a Londra nel 1670, con illustrazioni grandi, minuziose e piene di fantasia. Lo comprai e New York una decina di anni fa, è rarissimo. Mi costò un occhio, ma ne valeva la pena. I libri del resto sono una mia grande passione: a Tokyo passavo giornate intere nel quartiere dei librai a cercare cose interessanti tra le pile degli usati.
E un oggetto che l’ha accompagnata durante i suoi viaggi e a cui è particolarmente affezionato, c’è?
Più che esserci, c’era. Erano le mie macchine fotografiche. Una cinquantina di pezzi di tutte le epoche, che misi in un armadio quando decisi di smettere di fotografare. Fu lì che le trovò il ladro che me le ha rubate tutte. Si trattò certamente di un furto su commissione, visto che l’autore non toccò nient’altro, neanche l’argenteria. Corre voce, naturalmente non confermata, che la “talpa” sia stata proprio un giornalista venuto a intervistarmi… (ride). L’unica della raccolta che si è salvata è una Leika che avevo regalato in precedenza a un amico.
Insomma, mai fidarsi degli estranei. In casa o anche in viaggio?
In casa, di sicuro. Tempo fa mi ha chiamato un tizio che sosteneva di essere in un possesso dell’originale di una mia fotografia, ma che mancava la firma. “Venga qui e me la faccia vedere”, gli dissi. “Non importa – rispose lui – io gliela mando per posta, lei l’autografa e me la rimanda al più presto”. Capito? Chissà che foto era. E chissà se era davvero mia. Io non credo. Comunque gli dissi di no e da allora non l’ho più sentito. Ma così va il mondo.
E in viaggio?
In viaggio sono spesso gli altri a non fidarsi di te. Nel 1937 ero nel Sikkim, in Tibet, per la mia spedizione con il professor Tucci. Sapendo che andavamo in montagna, mi ero portato dietro gli sci: due pezzi di legno con i legacci di cuoio che avevo usato per le mie escursioni sull’Appennino e per prendere qualche lezione da Zeno Colò. Insomma, trovai un pendio che era bellissimo e non potei resistere: salii in cima e mi buttai per la discesa. In fondo dovevano esserci i portatori ad aspettarmi. Ma quando mi videro arrivare scivolando, tra gli spruzzi di neve e con quegli attrezzi ai piedi, scapparono a gambe levate e mi lasciarono solo: credevano che fossi un mago. Invece ero soltanto, credo, il primo sciatore mai visto in Tibet. Quella volta furono loro a non fidarsi.
Altre sciate indimenticabili?
Tante, ma due in particolare. La prima la feci sul Karakorum nel 1958, dai 6350 metri di un campo ai 5000 di quello più in basso: una sorta di tuffo verso il tramonto, su una superficie liscia, perfetta, velocissima. Una volata e una sensazione indescrivibili. La seconda è molto meno avventurosa e molto più buffa. La feci durante il nevosissimo inverno del 1929, qui a Firenze. La città era imbiancata. Io e i miei tre abituali compagni d’avventura sull’Appennino, Bernardo, Fofo e Tonino, scendevamo con gli sci dal Piazzale Michelangiolo a San Niccolò, poi prendevamo l’autobus e tornavamo su per sciare ancora. Facemmo la stessa cosa sulle pendici di Fiesole e di Monte Morello. I nostri compagni di scuola, al liceo Dante, ci chiamavano “i feroci”, perché eravamo inarrestabili.
Lei ha esplorato alcune delle montagne e dei passi più leggendari del pianeta…
Ho avuto questa fortuna e questo privilegio. Mi ricordo ad esempio il passaggio sul Passo Sebu nel 1937, a 5250 metri di quota, con la spedizione immersa nella neve fino alla vita, e il viaggio del 1958 sul Gasherbrum IV, quasi ottomila metri, con il mio amico Walter Bonatti. Ma sono indimenticabili anche tante escursioni sulle montagne toscane. Gli Appennini e le Apuane sono molto vicine al mio cuore, perchè ho vissuto lì i momenti più intensi della mia vita: il rifugio Scaffarola, la Pania, l’Alpe di Sant’Antonio, la foresta del Teso sono luoghi impressi in modo indelebile nella mia mente.
Vent’anni trascorsi in Giappone, dei quali cinque a Kyoto. Nessun italiano conosce il Giappone meglio e più profondamente di lei. Dopo tanto tempo e tanti viaggi, che cosa ancora l’affascina di quel popolo?
Moltissime cose, ovviamente. Ma ce ne sono alcune straordinarie. Una di queste sono i riti di successione della famiglia imperiale giapponese, ai quali ho dedicato un libro. Li ho potuti seguire relativamente da vicino perché ero là quando è scomparso Hirohito. Le cerimonie durano un anno intero e si rifanno alla fondazione mitica della dinastia, unificatrice di un Giappone primordiale diviso in due regni. Per questo si preparano due campi di riso, si aspetta che il riso maturi e poi lo si raccoglie: la fusione dei raccolti simboleggia l’unificazione del paese. E’ affascinante la convivenza di tutto questo con la vocazione dei giapponesi per la tecnologia e la modernità. Nel 2001 la figlia di Hirohito venne a trovarmi a casa qui a Firenze: aveva letto alcuni miei libri e voleva conoscermi. Fu un onore grandissimo.
Lei è non solo un viaggiatore dello spazio fisico, ma anche delle parole. Anzi, è un poeta metasemantico. Ovvero?
E’ un mio divertimento. La scienza etimologica spiega l’origine delle parole. Nel linguaggio metasemantico avviene esattamente il contrario: proponi dei suoni e attendi che il tuo subconscio e le tue esperienze interiori diano loro dei significati. La parola come musica. Con queste parole ho creato una specie di mio vocabolario e l’ho utilizzato poi per scrivere delle poesie, come Il lonfo o Il giorno ad urlapicchio. Le ho raccolte in un libro (“Gnosi delle fànfole“, Baldini e Castoldi, 1994, ndr) e ho trovato perfino qualcuno disposto a musicarle: Massimo Altomare. Ne è venuto fuori un disco riuscito talmente bene che è come se lo avessi inciso io.
A proposito del turismo modi e fuggi, lei ebbe a dire una volta che è sempre meglio che stare a casa. Conferma?
Certo che confermo.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da Loredana il 21/03/2012 17:58:42
Che personaggio affascinante!