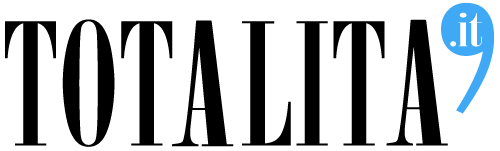Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Un giorno a Herat
Poche caramelle per il sorriso negli occhi di due bambini
Città di contraddizioni dove i soldati italiani sono amati e sopportati, e le carceri si riempiono a richiesta
di Steve Remington

Semplice malfattore o potenziale terrorista? In Afghanistan è un dubbio costante (foto by Chiara Giannini)
Herat-Italia, recitava il titolo del programma di Sky dedicato alla missione italiana è che ha coperto l’evento per settimane. Televisivamente l’associazione di sostantivi funzionava, nella realtà i fatti sono molto diversi.
Herat è un pezzo di Afghanistan con tutte le sue contraddizioni, macchiato da spruzzi di tricolore che attraversano la città, dove la cultura non ha niente a che vedere con la nostra. L’Italia è un’altra cosa, anche nell’immaginario collettivo degli afghani.
È un paese occidentale che ha portato un pezzo di Europa nel cuore di un Asia che, per certi aspetti, è ancora da decifrare. Un pezzo rappresentato ancora dal calcio e la pizza, non dalla nostra cultura, di quella non ci sono tracce.
Girare per le strade di Herat, per noi italiani, è un po’ come entrare nella macchina del tempo. I quartieri della città assomigliano ad alcuni paesi del sud Italia fine anni sessanta, dal punto di vista sociale, non certo strutturale.
Strade polverose, gente ferma all’angolo delle strade, mezzi d’emergenza e tanta povertà. Ma ciò che marca la differenza, e ci fa uscire dalla macchina del tempo, è la religione. Le donne con il burqua che viaggiano a bordo di improbabili mezzi a due ruote occupati da tre o quattro persone, sono il segno tangibile, la forbice che recide quel presunto Herat-Italia.

Ecco, sta in questo passaggio, forse, una delle chiavi per comprendere la contraddizione di questa missione di pace in un contesto di guerra.
Difficile non avvertire negli heratini il fastidio per la presenza dei militari. Difficile non comprendere le motivazioni sulla base delle quali gli ospiti iniziano ad essere un po’ ingombranti.
Difficile mettere in parallelo le ragioni della geopolitica e quelle del senso di appartenenza alla propria terra e alla propria religione. Perché qui la fede, il credo, è la cifra stessa della propria cultura. E non il suo contrario.
In questo Herat è perfettamente una città musulmana in un paese asiatico. Con le donne in carcere per aver ammazzato il marito o solo per aver provato a ribellarsi, rinchiuse in una struttura costruita dagli italiani, capace di accogliere anche i figli delle detenute.

Ma, come spesso accade in questi mosaici di azioni di guerra e cooperazione, troppo bello per essere vero. Nel senso che la visita alla casa di reclusione femminile, dimostra inevitabilmente il non uso dell’impianto, mostrato a comando alle delegazioni che arrivano ad Herat. Pareti linde, porte seminuove, detenute troppo preparate per essere rinchiuse lì.
Forse ad Herat usa così. Forse ad Herat le donne, che vivono sempre un passo dietro agli uomini, sono più utili a casa, a badare ai figli, che non in carcere. Salvo durante le visite delle delegazioni.
E se nel carcere maschile la finzione è ridotta ai minimi termini, ciò che si intuisce chiaramente è che gli afghani stanno cercando di mostrare al mondo di esser capaci di fare da soli.
Vedi detenuti in catene, ma sono catene figlie della caccia al talebano e al bandito che traffica in droga. Sono le catene con le quali gli afghani provano a spezzare la catena della violenza, quasi a voler dire che abbiamo gambe per camminare e braccia per la lavorare.
Questo sembrano voler dire nel loro mostrarsi, nel loro aprirsi all’occidente. Ma se gli chiedi quand’è che le forze della coalizione se ne devono andare il velo cade: “il più tardi possibile”, dice il capo della polizia, dopo averci detto che possiamo girare tranquillamente per le strade di Herat.
Insomma il badante fa comodo, basta che sia discreto. Come quando andiamo a visitare la moschea. Bella, nella sua chiave cromatica virata tutta sul blu. Bella per la sua essenzialità, bella perché centro della cultura di questa città.

Ma drammatica, al contempo. Ciò che vedi dentro e fuori sono i frutti di una povertà diffusa, tutt’altro che rarefatta.
Appena varchiamo l’uscita, scortati a vista, vedo due bambini piccolissimi. Ino e Ina, nomi di fantasia, si tengono per mano appoggiati al muro della moschea. Attorno altri bambini in bicicletta, forse più fortunati. Non puoi non guardarli, non puoi non pensare a cosa ci possa essere dietro ai loro pochi anni , cinque al massimo la bimba, tre il maschio. Mi frugo in tasca, mi sono rimaste delle caramelle, le prendo, mi inginocchio e gliele porgo.
Gli guardo negli occhi, sono meravigliosi, soli e tristi. Hanno paura, anche di allungare la mano. La guida si avvicina e gli parla, non so cosa gli dice. Ma so cosa dice il cuore. I due bimbi prendono le caramelle e parte un piccolo sorriso. “Quelle due caramelle, forse, saranno le uniche che mangeranno da qui a diciotto anni”, mi dice l’ ufficiale dei carabinieri che comanda la scorta.
“Se ci arrivano a diciotto anni”, mi scappa a denti stretti. Ci guardiamo senza parlare e ognuno sa di avere una parte di ragione. Qui la povertà è di casa. Altro che passi dentro la storia.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da Loredana il 03/04/2012 16:16:34
Un gesto forse piccolo, quello delle caramelle. Ma di sicuro ha lasciato un segno in quei cuori. E si comincia così, per arrivare ai grandi cambiamenti.
1 commenti per questo articolo
Attualità
Il professore e la dignità della scuola; una battaglia da Don Chisciotte?
EI FU. L'anniversario di un personaggio sicuramente controverso, ma le vestali del politically correct ....
IL KULTURKAMPF DELLA SINISTRA AMERICANA: il mito del piagnisteo che non finisce mai.
GIULIO REGENI: tra verità nascoste e ragione di stato.
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; la spada dell'arcangelo ci protegga dai moderni iconoclasti!
Il Fatto del Giorno
EI FU. L'anniversario di un personaggio sicuramente controverso, ma le vestali del politically correct ....
GIULIO REGENI: tra verità nascoste e ragione di stato.
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; la spada dell'arcangelo ci protegga dai moderni iconoclasti!
Il Biopotere: complottismo o incubo prossimo venturo, anzi già in corso?
La Messa per Pasqua? Inutile, si può pregare anche in bagno!