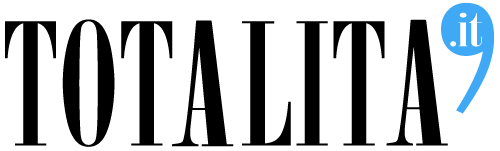Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

Maggio Musicale Fiorentino
Gli Intermedi della Pellegrina: ritorna a Pitti il fascino di una favola antica.
Grande successo dell'esecuzione musicale di Federico Maria Sardelli. La regia di Valentino Villa tra meraviglia e humor
di Domenico Del Nero

La meraviglia degli intermedi. Come deplorava tra gli altri anche il Lasca, la magnificenza di questi “spettacoli nello spettacolo” arrivava spesso a surclassare l’importanza della commedia che avrebbe dovuto essere il “piatto forte”; e così accadde, senza ombra di dubbio, anche per i celebri Intermedi della Pellegrina, rappresentati nel maggio 1589 in occasione delle nozze di Ferdinando I e Cristina di Lorena. Ma delle genesi dello spettacolo si è ampiamente trattato in un articolo precedente a cui si rimanda il lettore interessato. [i]
Il Maggio Musicale Fiorentino dunque ha puntato su una grande “scommessa”: riproporre questi veri e propri “monumenti” della civiltà musicale toscana (e non solo) del tardo cinquecento, nel momento in cui si vanno delineando grazie alla Camerata Fiorentina i presupposti del melodramma prossimo venturo, in forma scenica: non nella loro cornice originale (che non esiste più), ovvero il Teatro Mediceo degli Uffizi, ma in un ambiente comunque altamente suggestivo ed evocativo: Palazzo Pitti con la grotta di quel Bernardo Buontalenti che fu il anche il “regista” di quello spettacolo e le sue adiacenze. Così le suggestive composizioni di Antonio Archilei, Cristofano Malvezzi, Luca Marenzio, Giulio Caccini,Giovanni de’ Bardi, Jacopo Peri e Emilio de’ Cavalieri hanno potuto riprendere vita in una cornice comunque molto suggestiva e su strumenti originali.
Scommessa vinta? Per il pubblico presente, senz’altro, dato l’entusiasmo con cui ha accolto la proposta; unanime poi il consenso sulla parte musicale, mentre sulla regia di Valentino Villa non è mancato chi abbia arricciato il naso.
Non ci sono dubbi che se il paragone viene fatto con l’allestimento originale dello spettacolo, con i presupposti culturali che lo hanno generato e elementi di questo genere, non può essere che perdente. Ma di questo lo stesso regista si era ben reso conto e lo aveva anche molto onestamente dichiarato nella conferenza stampa di presentazione, dicendo che certo non gli sarebbe dispiaciuto poter “replicare” l’allestimento originale, ma le risorse di bilancio assolutamente non consentivano una operazione del genere.
Che fare, allora? Cercare di cogliere quello che era stato lo scopo originario sia del Buontalenti che dei musicisti: colpire, stupire, sorprendere il pubblico (all’epoca molto selezionato sia sul piano sociale che culturale) presentandogli qualcosa di diverso e inaspettato. E se si può dissentire su alcune soluzioni particolari o trovare forse un po’ troppo Kitsch qualche costume o qualche elemento, bisogna dire che nel complesso lo spettacolo è stato di altissimo livello sul piano musicale, ma tutto sommato più che soddisfacente anche su quello scenografico: sarà stata la cornice particolare del notturno, peraltro assai bene illuminato, in quella che fu la reggia dei Medici, dove vissero e si amarono Ferdinando e Cristina e in cui il granduca Mediceo regnò con la sua azione straordinariamente illuminata sia in campo politico che culturale; sarà stato il fascino dei bandierai degli Uffizi, ma anche l’efficacia di alcuni dei “quadri” presentati; in ogni caso, lo spettacolo è stato suggestivo e coinvolgente. In qualche caso può aver strappato un sorriso di incredulità o anche di dissenso, ma lo scopo che il regista si era prefisso, restituire un po’ di quella “meraviglia”, di quel senso di attesa, di curiosità e anche alla fine di esibizione e ostentazione (per quanto, nel caso dell’originale, sempre di altissimo livello) è stato decisamente raggiunto. Di più del resto non si voleva fare e con i mezzi a disposizione il regista ha lavorato bene, con inventiva ed estro; insieme ai costumi, senz’altro un po’ kitsch ma tutt’altro che sgradevoli, di Gianluca Sbicca e con alcuni figuranti che ricostruivano – ovviamente rivisitati - quadri viventi del classicismo cinquecentesco, giochi di specchi e brindisi con champagne; molto suggestivi gli effetti di luce, soprattutto nell’ultima “postazione” dello spettacolo, la grotta del Buontalenti. L’intermedio terzo, ad esempio, ovvero Il combattimento di Apollo con il serpente pitone, viene realizzato con un vero e proprio ….incontro di lotta tra due atletici figuranti con tano di guantoni e casco, che danno vita a una sorta di “lotta danzata”. Anche l’idea di spostare il pubblico – e naturalmente, l’orchestra e tutta la compagnia – in tre postazioni diverse è risultata suggestiva e coinvolgente, anche grazie ai figuranti e agli stessi cantanti che in alcuni momenti si mescolavano con il pubblico stesso “ Ho scelto il grado zero del racconto; un matrimonio. Mettiamo in scena una cerimonia che si è svolta più di quattrocento anni fa e che oggi si ripete, invitando gli spettatori a prendere parte ad un evento (…) in questo tentativo di ironica ricostruzione storica gli immaginari si confondono, la mitologia classica si innesta nel gusto della iconografia contemporanea, la vaporosità del racconto si innesta nell’essere effimero dell’immagine e la meraviglia si tinge di pennellate rosa, talvolta sfidando l’estetica kitsch. “. Così Valentino Villa e bisogna riconoscere che queste premesse sono state mantenute e ben realizzate.
Sul piano musicale, Federico Maria Sardelli è convinto, a ragione, che con gli Intermedi della Pellegrina siamo ormai difronte ai prodromi della Favola in musica che proprio a Pitti avrà i suoi natali undici anni dopo: e da lì, il melodramma. La sua lettura dei testi musicali contribuisce a sfatare un pregiudizio che si ha spesso nei confronti della Camerata de’ Bardi, di cui gli autori facevano parte o a cui comunque si riferivano: più teorici che artisti. Questi intermedi rivelano invece sia una straordinaria cultura musicale che una notevole capacità creativa: basti pensare al numero e alla varietà degli strumenti e al numero dei cantori, almeno sessanta. La lettura di Sardelli riesce a rendere perfettamente quello che era uno dei presupposti fondamentali della Camerata; il perfetto equilibrio tra parola e musica, l’intelligibilità del testo. Se ancora la monodia non regna sovrana come avverrà nella Euridicedel 1600, ve ne sono però chiari avvisi e segnali impressionanti. Del resto il filo conduttore degli intermedi, ideato proprio dalla guida della Camerata, il conte Giovanni de’ Bardi, è proprio il potere della musica, che Sardelli riesce a rendere anche coniugando l’aspetto “apollineo” con uno più “dionisiaco”, soprattutto nei cori e nei balli, come nel bellissimo brano conclusivo, o che nuovo miracolo, musicato da Emilio de’ Cavalieri. L’orchestra modo antiquo seconda perfettamente la sapiente guida del maestro, restituendoci, insieme al coro Ricercare Ensemble preparato da Roberto Allegrezza, una vera atmosfera di bellezza tardorinascimentale. Ben amalgamate e di sicura efficacia anche le voci dei solisti: Rossana Bertini affronta con sicurezza e competenza le pagine soliste più complesse: Elena Bertuzzi si distingue per una declamazione studiata e ben scandita. Buona anche la prova di Candida Guida , Marco Scavazza Mauro Borgioni e Paolo Fanciullacci; un canto che certo è lontano dai virtuosismi e dalla complessità di quello che si svilupperà col barocco, ma che proprio per questo conserva il fascino di una bellezza ormai perduta ….oseremmo dire da tragedia greca?
La recensione si riferisce allo spettacolo di sabato22 giugno.