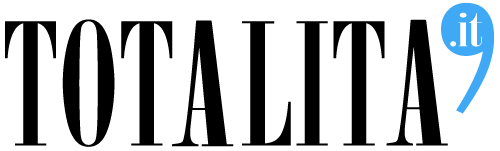Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

3 febbraio si celebra San Biagio
Protettore della gola, il santo viene ricordato in tutta Italia con riti e immancabili piccole ghiottonerie
A Roma nella chiesa a lui dedicata si va a farsi benedire la gola, che in questa stagione è cosa utilissima
di Marina Cepeda Fuentes

San Biagio Il miracolo del Bambino
La mattina del 3 febbraio, Festa di San Biagio, in molte chiese il sacerdote tocca la gola dei fedeli con l’imposizione di due candele incrociate; invece in alcune località, come ad esempio a Castel di Sasso, in provincia di Caserta, il parroco unge la gola con una penna di gallina immersa nell’olio benedetto.
Ebbene, sia l’imposizione delle candele che la penna di gallina avrebbero la virtù di preservare dal mal di gola o di aiutare a guarirlo. Queste usanze sono ispirate alla vita leggendaria di san Biagio che è anche patrono di Maratea, la bella cittadina lucana che si affaccia sul mare, dove sono custodite le sue reliquie portate dall’Oriente nel 732.
Biagio era un vescovo di Sebaste, in Armenia, che nell’anno 314 fu costretto a rifugiarsi in montagna per sfuggire a una persecuzione. Miracolosamente gli uccelli, insieme con altri animali, gli portavano del cibo e poi aspettavano la sua benedizione.
Quell’assembramento di bestiole incuriosì alcuni cacciatori di passaggio che si appostarono nelle vicinanze finché videro uscire dalla caverna il vescovo. Allora corsero dalle autorità a riferire quel che avevano visto.
Il santo vescovo venne arrestato e condotto a Sebaste. Durante il viaggio una donna gli portò il figlioletto che stava soffocando per una lisca conficcata in gola: Biagio lo benedisse e la lisca si staccò miracolosamente dalla gola. Da quell'episodio è nato il suo patronato sulla gola e i vari riti cui si è accennato.
Proseguendo il viaggio Biagio incontrò un’altra donna disperata perché un lupo le aveva sottratto il suo maiale, l’unico patrimonio che aveva – “Donna non ti affliggere”, rispose il santo alla sua richiesta di aiuto “presto lo riavrai”.
E subito arrivò il lupo restituendo docilmente il maiale.
Questo episodio, che è stato rappresentato da molti artisti, pittori o scultori, ha ispirato il suo patronato sugli animali e sugli agricoltori.
Per tutti questi fatti leggendari san Biagio divenne molto popolare nel Medioevo e perciò ancora perdurano riti e feste in suo onore.
A Monte San Biagio, in provincia di Latina, la sera del 2 febbraio, davanti all’altare maggiore della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, si benedice l'ampolla dell'olio d’oliva con cui ungere le gole nel giorno della festa; e con l’olio d'oliva si benedicono anche le cosiddette “dita del santo”, un pane tipico che ha la forma delle dita della mano e che viene distribuito come una sorta di amuleto perché si crede che collocandolo vicino alla gola potrebbe proteggerla dai malanni invernali, tosse, tonsille gonfie, ecc.
 Le panicelle
Le panicelle
L’usanza di distribuire pani benedetti durante il giorno di San Biagio è diffusa in tutta l’Italia e sopravvive persino in una grande e distratta città come Roma: basta recarsi la mattina della festa nella chiesa di San Biagio alla Pagnotta, detta anche San Biagio degli Armeni perché officiata da sacerdoti dell’Armenia, dove oltre alla distribuzione dei piccoli pani, si può avere anche l’imposizione delle candele sulla gola.
Curiosamente, a Milano si mangia una fetta del panettone natalizio che è stata conservata appositamente per la festività del santo.
 San Biagio della Pagnotta a Roma
San Biagio della Pagnotta a Roma
Invece a Taranta Peligna, in provincia di Chieti, si preparano le “panicelle” che sono pani caratteristici con la forma di una piccola mano aperta: dopo essere stati benedetti vengono distribuiti alla popolazione per propiziare l'aiuto del santo contro il mal di gola.
Ebbene, fino a qualche decennio fa la mattina del 1° febbraio un banditore comunicava per le vie del paese il nome del cittadino che metteva a disposizione la sua abitazione per la preparazione dell’impasto e per la confezione delle “panicelle”.
Attualmente le operazioni si svolgono invece nel forno comunale di Peligna dove molti cittadini vi si recano per impastare, darne la forma tipica e timbrare con un bollo speciale le “panicelle” che raffigurano san Biagio mentre miracola il bambino con la spina in gola della leggenda.
Molto popolari sono anche certi dolcetti detti “lattaciolu” offerti ai tanti pellegrini convenuti per la festa di San Biagio nell’antica abbazia di Piobbico di Sarnano, in provincia di Macerata.
E a Gergei, nel nuorese, il protagonista della festa è “su sussineddu”, un’intrecciatura fatta di “sessini” che sono dei giunchi cui si appendono arance, mele, caramelle, dolcetti e anche fiori e fiocchi. I coloratissimi “sussineddu” vengono portati in chiesa per la benedizione e poi nelle case: sempre che riescano a resistere agli assalti dei bambini per le vie.
Ma, come accennato, san Biagio è anche patrono di chi lavora nei campi: lo testimonia d’altronde un’usanza ancora viva in alcuni paesi del Nisseno e dell’Agrigentino, dove al momento dell’Offertorio durante la messa si portano frumento e altri cereali che, successivamente benedetti, saranno distribuiti ai contadini i quali a loro volta mescoleranno i chicchi con quelli della semina autunnale perché assicurino un buon raccolto.
Infine, a Militello Rosmarino, in Sicilia, si svolge una singolare processione. I devoti del santo trascinano il “fercolo di san Biagio”: molti dei quali sorreggono le “cordelle”, e cioé lunghe corde sottilissime e multicolori.
Il corteo, che per certi aspetti rammenta quello della Festa di San’Agata a Catania, attraversa le vie del paese per giungere in campagna dove ci sarà la rituale benedizione dei campi.
Durante il trasposto i fedeli gridano “San Vrasi, riri!” (San Biagio ridi!) mentre i fedeli offrono doni e denaro al santo mentre toccano la sacra effigie con fazzoletti e nastrini che serviranno come amuleti per proteggere la gola durante il resto dell’anno.
Completamente diversa è la festa in onore del santo che si svolge a Fiuggi, con la accensione di tronchi d’albero detti “stuzze”, e che è ispirata a un episodio leggendario.
Si racconta che in una lontana sera del 2 febbraio la cittadina ciociara, che una volta si chiamava Anticoli Campagna, venne circondata dai nemici che avrebbero voluto metterla a ferro e a fuoco. Ma grazie all’intervento di san Biagio sarebbero apparvero gigantesche fiamme che allontanarono gli assalitori.
In ricordo di quel prodigio ogni anno si accendono sulla piazza della cittadina alcuni tronchi d’albero trasportati dai giovani del luogo, “le stuzze”, appunto.

Probabilmente questa tradizione è una eco degli antichi riti di purificazione in onore della dea Giunone. Riti che si ritrovano anche nella Festa della Candelora del 2 febbraio.
Piaciuto questo Articolo? Condividilo...
-
Inserito da NewBalance547 il 15/11/2014 11:02:08
Xs235New@163.com
1 commenti per questo articolo
Cultura
Grande diva: Jessica Pratt incanta con Norma. Uno spettacolo di alto livello trionfa al Maggio Musicale
RIGOLETTO: trionfo del capolavoro verdiano al teatro del Maggio
Magiche sinestesie, classiche armonie: a gennaio al Maggio Musicale rivive l'incanto di Fantasia
Sorrisi e risate amare. Due opere in un atto molto particolari in arrivo al Maggio: Mavra e Gianni Schicchi
Una Violetta tradizionale ma molto apprezzata. Pieno successo dell'ultima Traviata sul proscenio fiorentino